Introduzione a Marx e il materialismo dialettico
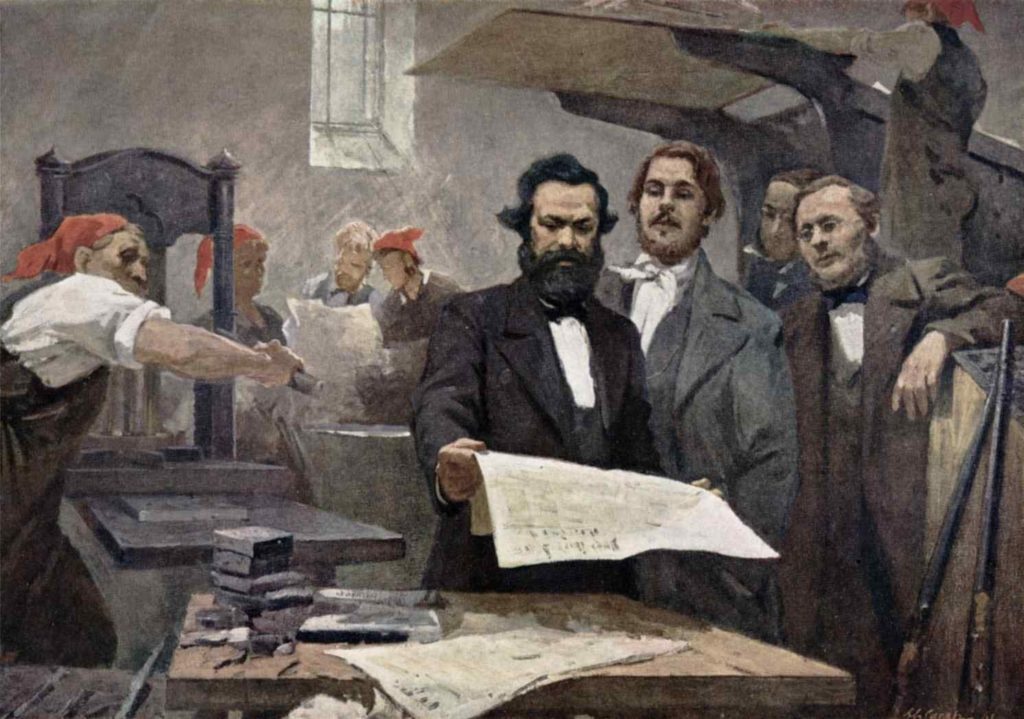
Daniele Burgio, Giulio Chinappi, Massimo Leoni, Alberto Lombardo, Martino Marconi, Vanna Melia, Roberto Sidoli, Pietro Terzan
Karl Marx: «Per il suo fondamento, il mio metodo dialettico non solo è differente da quello hegeliano, ma ne è anche direttamente l’opposto. Per Hegel il processo del pensiero, che egli trasforma addirittura in soggetto indipendente col nome di idea, è il demiurgo del reale, che costituisce a sua volta solo il fenomeno esterno dell’idea o processo del pensiero. Per me, viceversa, l’elemento ideale non è altro che l’elemento materiale trasferito e tradotto nel cervello degli uomini». (Poscritto alla seconda edizione del Capitale, 24 gennaio 1873)
Hồ Chí Minh: «Il marxismo ha il vantaggio del metodo dialettico» (“Ho Chi Minh on religion and belief issues”, in Social Sciences Publishing House, Hanoi, 1996, p. 152).
Che Guevara: «Non si pretende che si faccia uno studio memorizzato di ogni testo né che si applichino, schematicamente, i concetti dei testi; si tratta di insegnare a pensare e insegnare a pensare con la base del materialismo dialettico», in L’ideario di Ernesto “Che” Guevara, italiacuba.it.
Decine di milioni di esseri umani hanno aderito in passato e tuttora, all’inizio del terzo millennio, approvano almeno le linee generali del materialismo dialettico: partendo dalla Cina attuale con i suoi cento milioni di iscritti al Partito Comunista fino al Vietnam prevalentemente socialista, passando dal Laos, da Cuba e dal Venezuela bolivariano per giungere infine a una sezione minoritaria, ma negli ultimi anni crescente, degli intellettuali e degli operai antagonisti che operano nelle metropoli imperialiste.
Anche ai nostri giorni e all’inizio del terzo millennio, a dispetto di una furibonda e continua campagna anticomunista su scala mondiale che dura da più di tre decenni, milioni di esseri umani tuttora, come avvenne del resto su scala planetaria a partire dal 1917-25, aderiscono alle concezioni materialistiche e dialettiche.[1]
Si tratta di un fenomeno ideologico-culturale impressionante per estensione quantitativa e resilienza temporale ancora all’inizio del Ventunesimo secolo ma sul quale, almeno in terra occidentale per una serie di motivi su cui torneremo, è stato elaborato e scritto molto poco, al di là di rapidi e frettolosi accenni all’interno delle diverse storie del marxismo pubblicate nel corso dell’ultimo secolo e di analisi contenute in rari saggi di chiara matrice anticomunista, come l’ormai remoto libro di G. A. Wetter, intitolato Il materialismo dialettico sovietico.[2]
Inoltre, il processo di snaturamento e falsificazione, di livello sofisticato, compiuto contro le tesi centrali del materialismo dialettico ha via via conosciuto una serie di famosi protagonisti, nel mondo occidentale.
Infatti, nel 1947, assieme a M. Horkheimer, T. Adorno pubblicò, come presunto marxista e futuro collaboratore di pubblicazioni culturali finanziate dalla CIA, il saggio intitolato Dialettica dell’illuminismo, nel quale si era cercato di far passare come rivoluzionaria e antagonista una vacua e assurda tecnofobia, completamente opposta al prometeismo cooperativo di Marx.[3]
Ma non solo.
Alcuni anni fa si è arrivati al punto che un noto filosofo anticomunista come S. Žižek, nel suo tentativo di spacciarsi per marxista, aveva presentato la sua banale ricopiatura e riproduzione del grande idealismo oggettivo, elaborato due secoli prima da Hegel, addirittura come una sorta di rinnovamento del materialismo dialettico, pur non avendo le sue tesi alcuna affinità e connessione con quest’ultimo.[4]
Questo libro, assieme a quelli che seguiranno, cerca di iniziare a colmare un particolare buco nero teorico indicando gli elementi principali del materialismo dialettico, oltre a smentire e confutare il presunto e inesistente divorzio tra Marx e il materialismo dialettico.
Larga parte degli studiosi, dei marxologi e dei teorici del marxismo occidentale, infatti, hanno cercato di staccare e separare Marx dalla filosofia marxista sviluppatasi negli ultimi due secoli, di solito agitando lo spauracchio del famigerato “diamat stalinista”.
Hanno completamente torto.
Questa cerchia intellettuale da molti decenni cerca inoltre di far dimenticare che Marx scrisse una splendida tesi di laurea filosofica, e fra l’altro su pensatori materialisti quali Democrito ed Epicuro, non certo un trattato di giurisprudenza, di chimica organica o altro.
Cerca di obliterare che Prometeo e la plurimillenaria corrente teorica e pratica del prometeismo (sdoppiata al suo interno tra un prometeismo comunista o “rosso”, centrato sulla liberazione collettiva, e controtendenze di natura classista o schiavista, un prometeismo “nero” alla Y. Harari, che esalta invece l’innovazione come profitto individuale) trovò il suo miglior erede e sviluppatore proprio in Karl Marx, fin dalla sua tesi di laurea del 1841.[5]
Tenta di evitare il “fatto testardo” (Lenin) in base al quale Marx nel 1843 elaborò un magnifico e iperfilosofico testo, intitolato in modo inequivocabile Per la critica della filosofia del diritto di Hegel.
Il rapporto tra uomo e natura, il “ricambio organico” fra di loro risulta inoltre un tema centrale – e squisitamente filosofico – contenuto nei Manoscritti economico-filosofici del 1844, elaborati da Marx molto prima della genesi delle teorie ecologiste nelle loro più diverse declinazioni.
Se non bastasse, poi, il libro di Marx ed Engels pubblicato nel 1845 e intitolato La sacra famiglia risulta un’opera densa di spunti analitici, come ad esempio una breve ma lucidissima storia del plurisecolare materialismo all’interno della filosofia occidentale.
E le celebri Tesi su Feuerbach, pubblicate postume nel 1888? Al loro interno si tratta di praxis, criteri di verità e oggettività, non certo di edilizia o gastronomia…
Seguono poi le indicazioni contenute in una sua lettera ad Engels del 16 gennaio 1858, nella quale si lodava la Logica di Hegel, e, quindici anni dopo, nello splendido poscritto alla prima edizione del Capitale, datato 24 gennaio 1873, nel quale il genio di Treviri chiarì il suo rapporto con Hegel, cos’era l’idealismo oggettivo di Hegel e quale risultasse invece la concezione dialettica marxiana del mondo, oltre a fornirci un formidabile abbozzo del principio fondamentale della logica dialettica: ossia A = A e anche non A, formula da intendersi come l’unità dialettica di permanenza e cambiamento in ogni ente del cosmo e in ogni secondo dell’esistenza di qualunque fenomeno naturale.
Siamo in presenza di altre strade luminose in campo filosofico, ma sigillate e chiuse per sempre, almeno per la maggioranza dei marxologi e dei marxisti occidentali: partendo dall’agnostico – in campo filosofico – Karl Kautsky fino agli esangui analisti del presente di Marx, quali Favilli e Musto per limitarci all’Italia.[6]
«Ho seminato draghi e ho raccolto pulci», si sfogò giustamente Marx in un aforisma che si adatta perfettamente anche alle opere della parte maggioritaria dei suoi biografi occidentali.[7]
Nelle metropoli imperialiste solo l’ormai dimenticata opera del gesuita J.-Y. Calvez, Il pensiero di Karl Marx, espose e delineò dopo il 1953 due verità indiscutibili: e cioè che fu Marx, e non certo Engels, il creatore principale del materialismo dialettico, mentre quest’ultimo rappresentava in passato e costituisce tuttora un tassello importante del marxismo e del socialismo scientifico.
Critica e anticritica
A nulla vale l’obiezione fraudolenta secondo cui Marx non autodefinì mai la sua concezione del mondo, ivi compresa l’analisi del posto via via acquisito dal genere umano nell’universo, con le parole materialismo dialettico.
In primo luogo, il genio di Treviri (1818-1883) non classificò mai come marxismo la sua stessa teoria, ma persino i marxologi più anticomunisti descrivono e criticano un’entità teorica che essi stessi quasi sempre denominano come “marxismo” e non con il termine utilizzato da Marx, e cioè socialismo scientifico.[8]
Nel gennaio 1873, come si è già visto nella citazione iniziale, fu inoltre proprio Karl Marx a utilizzare in modo combinato, e in poche righe, termini inequivocabili quali idea e idealismo, materia e metodo dialettico diverso da quello di Hegel, e così via: si tratta di un pezzo meraviglioso che non solo chiarisce definitivamente la questione in oggetto ma, simultaneamente, non può che gettare nello sconforto alcuni teorici confusamente anticapitalisti come Diego Fusaro, con la sua errata convinzione di un inesistente rapporto di stretta derivazione teorica tra l’idealismo oggettivo e Marx.[9]
Fu il russo G. V. Plechanov (1856-1918) il primo marxista a utilizzare e popolarizzare con particolare successo sia il termine che la concezione del mondo del materialismo dialettico, partendo dal suo libro del 1895 intitolato Saggio sullo sviluppo della concezione monista della storia: in tale scritto Plechanov notò, con grande capacità di sintesi e giustamente, che «il materialismo dialettico è una filosofia dell’azione», anche se il filosofo russo dal 1904 non rimase fedele a tale tesi e diventò un nemico di Lenin, dei bolscevichi e della Rivoluzione d’Ottobre.[10]
Si è anche cercato di negare, tra le altre menzogne, che al geniale Marx non fosse chiara la priorità temporale e ontologica della natura rispetto alla specie umana.
Tratteremo meglio questa tematica nel capitolo dedicato all’ontologia marxista, ma già ora è fin troppo facile ricordare che nel loro libro intitolato L’ideologia tedesca proprio Marx ed Engels affermarono, in modo perentorio, che «è vero che la priorità della natura esterna rimane ferma».
Nella sua Introduzione a Per la critica del’ economia politica, Marx, nel 1857, constatò inoltre che persino «la più semplice categoria […] non può esistere altro che come relazione unilaterale astratta di un insieme vivente e concreto già dato», ossia un insieme vivente e concreto che esiste indipendentemente dalla categoria e dal pensiero che ragiona e riflette su di esso.
Risultano invece ormai prive di significato le rozze critiche al materialismo dialettico che lo accusavano di non analizzare e anzi respingere la tematica dello spirito, delle idee, sogni ad occhi aperti, progetti e ricordi umani, come fece ad esempio nel 1944-48 l’esistenzialismo francese con Sartre, Merleau-Ponty e Simone de Beauvoir.[11]
Scrisse giustamente a tal proposito il grande pittore francese Georges Braque che «il vero materialista, più scende nella materia, più esalta la spiritualità».
Per l’appunto, Karl Marx esaltò la progettualità umana nel primo libro del Capitale attraverso il suo geniale processo di confronto tra l’ape e l’architetto; sempre nel quinto capitolo del primo libro del Capitale, il genio di Treviri lodò la capacità predittiva e creativa dell’uomo indicando che, attraverso gli strumenti di produzione, quest’ultimo aveva altresì allungato prometeicamente “la sua statura”, aumentando enormemente i suoi poteri e potenzialità; Lenin, a sua volta, nei suoi Quaderni filosofici, indicò che lo spirito era il risultato più alto della materia, e le categorie teoriche umane a loro volta il prodotto più alto dello spirito. Anche Mao Zedong sottolineò la rilevanza del processo dialettico secondo il quale la materia si trasforma a determinate condizioni di coscienza e pensiero, mentre a sua volta lo spirito umano si trasforma in pratica sociale che si cristallizza e oggettivizza in cose e prodotti, partendo dal primo chopper del Paleolitico di più di due milioni di anni fa fino all’intelligenza artificiale dell’inizio del terzo millennio.[12]
“Il materialismo dialettico rappresenta solo una dottrina metafisica, perché presuppone arbitrariamente l’indipendenza dell’oggetto dal soggetto, ossia dalla soggettività umana che conosce l’oggetto”.
Innanzitutto, dal 1917 a oggi sono state scoperte, in modo per nulla arbitrario, come minimo cento miliardi di galassie: tali oggetti ruotavano nello spazio-tempo prima e indipendentemente dall’homo sapiens e dai suoi antenati ominidi, a meno di non supporre che le più di cento miliardi di galassie osservate dopo il 1917 siano state create ex novo, costruite dal nulla da parte dei vari astronomi-osservatori dell’ultimo secolo.
Non è data alcuna terza ipotesi, e la seconda risulta a sua volta così folle e assurda da non poter essere enunciata apertamente neanche dal più pazzo filosofo idealista.
Inoltre, un grande filosofo e idealista come Hegel ha ben definito l’essenza più profonda dell’idealismo (di qualunque forma di idealismo, a partire da quello di matrice religiosa) nella sua opera Scienza della logica, affermando, con estrema competenza e decisione, che «l’idealismo della filosofia consiste soltanto in questo, nel non riconoscere il finito come un vero essere».[13]
La nostra Via Lattea?
È grande, certo, ma costituisce in ogni caso un “ente finito”: quindi, per qualsiasi forma e corrente di idealismo, non costituisce un “vero essere” che, per l’appunto, va oltre il finito, va oltre le diverse forme di manifestazione della materia.
Per alcune forme di idealismo il “vero essere” è rappresentato da Dio.
Per l’idealismo hegeliano, il “vero essere” è costituito dallo Spirito Assoluto.
Ai nostri tempi, il “vero essere” può essere immaginato come Matrix, o uno dei suoi cloni “infiniti”.
Sfugge viceversa all’accusa di avere una natura metafisica proprio il materialismo dialettico, basato sul presupposto dell’esistenza reale, oggettiva e indipendente dal genere umano degli enti naturali, a partire ovviamente dalle oltre cento miliardi di galassie via via ritrovate e osservate per la prima volta dalla nostra specie solo a partire dal 1917.
“Di recente, il filosofo russo-tedesco Boris Groys ha accusato il materialismo dialettico di essere una forma rinnovata di gnosticismo”.
Lo gnosticismo rappresenta e viene riconosciuto come una forma speciale di conoscenza religiosa, dei misteri e della grandezza della divinità: religione a cui il materialismo dialettico ha rovesciato la relazione decisiva mostrando che non è stato dio, o le divinità, a creare gli uomini, ma viceversa questi ultimi a ideare la figura di dio/degli dei: come ad esempio avvenne nel caso della religione induista dove, all’interno dell’antichissimo testo del Rig Veda, si legge che gli dèi sono trentatré, mentre i nomi dei diversi numi citati nel libro in oggetto risultano molti di più.
Inoltre, le multiformi teorie gnostiche, sorte circa due millenni or sono, trovarono un’ulteriore elemento comune al loro interno nella tesi secondo la quale la salvezza spirituale era riservata a pochi individui eletti, dotati di particolari e speciali conoscenze spesso occultate al mondo esterno, mentre la maggioranza degli uomini era destinata alla dissoluzione: è appena il caso di rilevare che, invece, il marxismo intende salvare e rendere prospero, sulla Terra e in questa vita, l’intero genere umano a partire dai proletari di tutto il mondo, senza dottrine segrete e anzi esponendo «in faccia al tutto il mondo il loro modo di vedere», come scrissero Marx ed Engels all’inizio del loro magnifico Manifesto del Partito Comunista.[14]
È stato altresì obiettato da varie parti che il materialismo dialettico non è servito a niente nel variegato campo delle scienze naturali, mentre queste ultime hanno invece prodotto reali scoperte e nuove conoscenze.[15]
A questo punto, riteniamo utile distinguere anche la distinzione tra due funzioni complementari della dialettica marxista, quella descrittiva e quella predittiva. La prima fornisce uno strumento analitico per cogliere nei processi naturali e sociali l’unità e la lotta degli opposti, descrivendo come, dopo lunghi periodi di accumulazione quantitativa, si possano produrre veri e propri salti di qualità. Un esempio paradigmatico è offerto proprio dalla teoria degli “equilibri punteggiati” di N. Eldredge e S. J. Gould, secondo cui l’evoluzione biologica alterna fasi di stasi a cambiamenti relativamente rapidi, proprio come nella dialettica marxiana.
La funzione predittiva, invece, nasce sulla base dell’analisi delle contraddizioni interne ai rapporti di produzione, grazie alla quale Marx prevede che all’accumularsi di tali tensioni, a condizioni determinate, subentrino rotture qualitative e rivoluzioni sociali. Questa previsione “di natura generale” è esplicitata già nella prefazione alla Critica dell’economia politica del 1859, dove Marx indica che la crescita delle contraddizioni tra forze produttive e rapporti di produzione giunge a un punto critico, aprendo la via a trasformazioni rivoluzionarie.
In tal modo, la dialettica marxiana non si limita a descrivere i fenomeni, ma orienta anche l’azione politica attraverso la previsione dei momenti in cui le strutture esistenti possono crollare e lasciare spazio al nuovo. Detto questo, la funzione predittiva del materialismo marxista non deve essere considerata alla stregua di una sorta di capacità profetica o come una visione determinista della realtà, interpretazioni errate che tuttavia hanno ancora diversi seguaci sia tra i marxisti che tra gli oppositori del marxismo. Al contrario, questa capacità di prevedere l’emergere del nuovo, sia nei processi naturali che nella storia, rappresenta una delle prove più forti della scientificità del materialismo dialettico.
Innanzitutto, come visione scientifica del cosmo e, allo stesso tempo, metodo creativo e antidogmatico di analisi e previsione, il materialismo dialettico è servito a Richard Levins, uno dei padri della scienza ecologica, per analizzare i loop e le dinamiche di azione-reazione, con le loro diverse variabili, in tutte le tipologie di situazioni ecologiche.[16]
Il materialismo dialettico è servito anche a N. Eldredge e S. J. Gould al fine di elaborare la loro corretta teoria sugli equilibri punteggiati, in base alla quale l’intero processo di trasformazione delle diverse specie viene contraddistinto anche da balzi e salti qualitativi (relativamente) molto rapidi, dopo lunghi periodi invece passati dalle diverse forme di organismi viventi senza variazioni notevoli al loro interno.[17]
La visione del mondo materialistica basata sul potere trasformatore della pratica sociale ha aiutato anche il geniale agronomo cinese Yuan Longping (1930-2021) nella sua opera di sviluppo di quel riso ibrido che ha ottenuto un’eccezionale e sempre crescente successo, a partire dal 1973: un riso ibrido che ha incrementato enormemente la resa per ettaro del cereale in oggetto in Cina e in una parte importante del globo.[18]
Andando indietro nel tempo, inoltre, l’utilizzo della cosmovisione marxista influenzò in modo fecondo e significativo il lavoro teorico e i risultati via via ottenuti da scienziati di alto livello quali J. D. Bernal, J. B. Haldane, C. Caudwell, M. Prenant, I. I. Šmalʹgauzen e C. Waddington, oltre che numerosi ricercatori e scienziati sovietici a partire da K. E. Ciolkovskij, il padre mondiale dell’astronautica, e I. V. Mičurin, uno dei fondatori della scienza epigenetica che studia i cambiamenti fenotipici ereditati, ma avvenuti senza mutamenti genetici.[19]
In ogni caso, il primo sottoprodotto di valenza generale del processo di sviluppo bisecolare della scienza filosofica marxista consiste nella chiara ed inequivocabile dimostrazione, basata sulle molteplici scoperte scientifiche degli ultimi secoli, della priorità sia temporale che ontologica della materia rispetto allo spirito, con la derivata inesistenza di dei, divinità e/o dell’idea assoluta di hegeliana memoria.
Nell’ultimo secolo, si è altresì assistito al particolare, importantissimo e misconosciuto fenomeno dell’ipermaterializzazione dell’universo.
A livello cosmico, infatti, alla solitaria, unica e isolata galassia conosciuta dal genere umano ancora nel 1916, ossia la nostra Via Lattea, si sono via via aggiunte come minimo altre cento miliardi di strutture galattiche, in precedenza completamente sconosciute allo spirito e alla coscienza della nostra specie, le più antiche delle quali si sono formate circa 13,3 miliardi di anni fa e assai prima della genesi del processo di autocoscienza dell’uomo.
A livello della Via Lattea, in seconda battuta, si sono scoperte da poco i due oggetti più giganteschi che si riproducono al suo interno: si tratta delle bolle di Fermi, due strutture costituite da gas caldo e raggi cosmici che si estendono sopra e sotto il piano della nostra galassia, per un’immensa ampiezza complessiva equivalente a ben cinquantamila anni luce e che sono state scoperte dallo spirito e dalla coscienza dell’homo sapiens da poco, solamente nel 2010.
Secondo risultato positivo: il processo di verifica, sempre fatti scientifici alla mano, che sia il cosmo che la Terra esistevano e si muovevano nello spazio-tempo prima e indipendentemente dal genere umano, con la derivata fallacia del perno fondamentale dell’idealismo soggettivo secondo cui nessun oggetto può esistere senza soggetto, ossia senza la presenza fisica e l’osservazione del soggetto-uomo.
Le scienze naturali hanno dimostrato in modo indiscutibile che la Terra si formò 4,54 miliardi di anni or sono, in totale assenza di uomini e con l’assoluta impossibilità per la nostra specie di riprodursi per centinaia di milioni di anni, durante la prima fase arcaica di sviluppo del nostro pianeta: milioni e milioni di anni nei quali l’oggetto-Terra ruotò nello spazio senza la presenza o l’osservazione del soggetto-uomo, ritenuto invece sempre indispensabile dal correlazionismo e dall’idealismo soggettivo.
In terza battuta, inoltre, va ricordato come gli elementi chimici pesanti (oro, platino, uranio, ecc.), presenti sul nostro pianeta e negli stessi uomini, costituiscano in gran parte il risultato dell’esplosione di una moltitudine di supernove, stelle morenti che raggiungono per brevi istanti temperature e luminosità straordinarie e che incendiarono fugacemente lo spazio in completa assenza del soggetto-uomo, quasi sempre molte decine o centinaia di milioni di anni prima della comparsa dei più remoti ominidi, circa sei milioni di anni fa.
Sempre a titolo di esempio gli umili lombrichi, tanto apprezzati da Charles Darwin, si sono adattati alla vita sulla terraferma circa 200 milioni di anni fa.
Da tale momento essi incessantemente “arano il terreno” contribuendo sensibilmente a sostenere la ritenzione dell’acqua nel suolo, oltre a trasformare la materia organica morta in una serie di elementi chimici vitali per la crescita delle piante: il tutto in completa assenza anche dei nostri più lontani antenati ominidi, almeno per il 97% della dinamica di riproduzione dei lombrichi sul terreno.
Sempre stando vicino ad esso, risulta altresì facile ricordare come in Australia siano stati ritrovati piccoli zirconi con un’età di circa 4,3 miliardi di anni: tempi nei quali qualunque forma di vita sulla Terra, anche solo a causa del suo calore primordiale, era assolutamente impossibile.
Nell’estate del 2025, è stata altresì osservata per la prima volta la cometa 3I/ATLAS, proveniente da un’altra zona della Via Lattea e la cui età viene stimata attorno ai sette miliardi di anni: un ente naturale, quindi, che si muove nello spazio da circa sette miliardi di anni prima che comparissero sulla Terra i nostri più remoti antenati ominidi.
Le nane brune costituiscono a loro volta delle stelle capaci di innescare solo la fusione del deuterio: sono state osservate per la prima volta nel 1988 (quindi nel 1987, nel 1986, nel 1985, ecc. non esistevano, stando almeno alla tesi secondo cui “nessun oggetto senza soggetto”) e ruotano nel cosmo per miliardi di anni, essendosi dunque formate miliardi di anni prima che il primissimo neonato ominide (e primo “soggetto-osservatore”) emettesse il suo primo vagito nell’universo.
Certo, purtroppo nel mondo occidentale e ancora nel 2008 Sarah Palin, allora candidata repubblicana alla vicepresidenza degli Stati Uniti, aveva sostenuto senza problemi che 6000 anni fa gli uomini e i dinosauri coesistevano e coabitavano sul nostro pianeta: anche un breve corso di filosofia marxista l’avrebbe sicuramente aiutata, a nostro avviso.[20]
Come sottoprodotto di queste due corrette sintesi teoriche, basate sull’analisi dell’attività e dei fatti concreti, è derivata altresì l’importante acquisizione di una lucida autocoscienza da parte del marxismo, a partire dalla Sacra Famiglia del 1845, rispetto alla lotta plurimillenaria che si riproduce quasi senza sosta in campo filosofico (il “kampfplatz”, il campo di battaglia ben descritto da Kant) tra materialismo e idealismo: conflitto principale del resto riconosciuto già da Platone nella sua opera Il sofista, raffigurando lo scontro tra “amici della Terra” e “amici delle forme”, oltre che attestato anche dalla presenza concreta dei filosofi atei denominati cārvakā già nell’India vedica di tre millenni fa.[21]
E, sempre partendo dal corretto primato ontologico e temporale della materia sulla coscienza, Karl Marx, nei suoi Manoscritti del 1844, riuscì ad individuare il reale rapporto tra pensiero ed essere.
«Pensare e essere sono senza dubbio distinti, ma allo stesso tempo pensiero e essere sono in unione l’uno con l’altro», scrisse Marx: e cioè essi formano due elementi differenti ma altresì collegati in una polarità dialettica, creando pertanto sia unità che contraddizioni e asimmetrie tra i due lati opposti dell’interrelazione reciproca.
Se da un lato, infatti, sicuramente “vi sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quanto tu ne possa sognare con la tua filosofia”, come disse Amleto-Shakespeare, dall’altro lato non tutto ciò che opera ed esiste nell’intelletto sussiste necessariamente nella realtà e nel mondo naturale, come sottolineò giustamente il monaco e filosofo Gaunilone nell’undicesimo secolo, descrivendo in modo cosciente un’immaginaria isola perduta senza padroni e piena di ricchezze, in un’aperta e importante polemica contro il teologo di matrice idealista Anselmo d’Aosta.
Il marxismo ha altresì fatto diventare la filosofia una scienza – mediante una serie di “esperimenti” e verifiche basate sulla stessa storia, multiforme e contradditoria, dell’analisi teoretica a partire dal pensatore greco Talete – anche introducendo un secondo livello di autocoscienza al suo interno, e cioè il carattere di classe che segna e contraddistingue qualsiasi corrente filosofica dal settimo secolo a.C. fino a oggi e all’inizio del terzo millennio.
Per limitarci solo ai pensatori occidentali con un grado più elevato e resiliente di autorevolezza, il grande Aristotele sostenne proprio all’inizio del suo libro Politica la piena legittimità della schiavitù, valutando il servo sottomesso come una sorta di strumento di lavoro parlante; Tommaso d’Aquino, teologo medievale rinomato per alcuni secoli in Europa, a sua volta giustificò la servitù della gleba dal momento che dal mondo stesso «ne deriva per conseguenza logica che vi debba essere una classe inferiore, soggetta, che provveda alle necessità materiali della vita»; filosofi famosi come Locke e Voltaire sostennero a loro volta sia la proprietà borghese che il carattere positivo del traffico di schiavi dall’Africa al continente americano attuato con la lucrosa, sanguinaria e plurisecolare azione congiunta delle formazioni statali e dei capitalisti europei.[22]
Sul fronte di classe opposto la matrice comunista, rivoluzionaria e centrata sul proletariato di Karl Marx, risulta estremamente chiara, evidente e indiscutibile, fin dall’estate del 1843, quando in una lettera ad Arnold Ruge il geniale pensatore di Treviri descrisse “il sogno di una cosa” e di un mondo senza oppressione e sfruttamento, mentre quasi negli stessi mesi Marx individuò nella classe operaia la soggettività sociopolitica che avrebbe liberato dalle catene della schiavitù capitalistica se stessa, oltre all’intero genere umano.
Il terzo successo si ritrova nell’aver individuato, in pieno accordo con le scienze neurologiche, il pensiero come il risultato centrale dell’attività celebrale umana e dell’interconnessione tra i miliardi di neuroni che formano la nostra corteccia celebrale.
Iniziando con il grande medico Alcmeone di Crotone, vissuto nel sesto secolo a.C., si sono via via accumulate nei secoli una massa impressionante di prove inattaccabili, le quali attestano come sia il cervello il centro nevralgico del pensiero e non certo il cuore, la ghiandola pineale di Cartesio o l’introvabile anima immateriale: è sufficiente ricordare, per gli ultimi decenni, le ricerche condotte da A. R. Damasio sui meccanismi neuronali responsabili delle emozioni e dei sentimenti, oltre che sulle regioni cerebrali aventi un ruolo nello sviluppo delle malattie psichiche.[23]
Un ulteriore frutto positivo si ritrova nella tesi marxista, anch’essa basata su millenni di attività scientifica, secondo cui il genere umano è in grado di conoscere via via sempre nuovi fenomeni, processi e oggetti naturali, in una dinamica potenzialmente illimitata: la presunta inconoscibile “cosa in sé” di matrice kantiana si trasforma a mano a mano in una “cosa per noi”, ossia da noi studiata e osservata sempre più a fondo.
Quinta conquista teoretica del materialismo dialettico: la scoperta delle infinite potenzialità della nostra specie con in testa la sua capacità di autotrasformazione, a partire dall’autocostruzione di quel “monolite nero” (Kubrick) formato dai primissimi strumenti di produzione, dai chopper con i quali l’uomo elevò la sua statura “a dispetto della Bibbia”, come notò Marx nel quinto capitolo del primo libro del Capitale. Solo a titolo di paragone, viceversa nel 2012 ben il 46% degli statunitensi credeva ancora nell’ideologia del creazionismo, ritenendo pertanto sia che Dio avesse creato l’essere umano, sia che lo avesse forgiato nella sua forma attuale, del presente.[24]
Un altro sottoprodotto si trova nell’individuazione delle leggi generali dell’universo e della dialettica, intesa come riproduzione a livello teorico di quest’ultimo, a partire dall’unità e lotta tra tendenze e controtendenze in ogni cosa, oltre che dall’interconnessione universale fra ogni fenomeno e dal loro continuo, anche se a volte minimo, processo di trasformazione.
La settima conquista di natura analitica si ritrova nella connessione dialettica, da creare e riprodurre senza sosta, tra pratica sociale, derivata teoria (leggi scientifiche, ecc.) basata sulla praxis e nuove pratiche, in una spirale potenzialmente senza limiti. Anche il grande scienziato R. P. Feynman notò che “l’esperimento è l’unico giudice della verità scientifica”, in sintonia con le categorie gnoseologiche espresse sinteticamente da Marx nelle sue Tesi su Feuerbach del 1845 e in base alle quali “è nell’attività pratica che l’uomo deve dimostrare la verità, cioè la realtà e il potere, il carattere terreno del suo pensiero” (seconda tesi su Feuerbach).
Inoltre, fin dal 1843 e dalla Critica della filosofia del diritto di Hegel, Marx espose parzialmente il processo di trasformazione della possibilità e della potenzialità in realtà concreta, sottolineando come la teoria (una forza solo embrionale in campo politico-sociale, quando e se separata da gruppi sociali che la facciano propria) si trasforma invece in una forza materiale “non appena si impadronisce delle masse”.
Nel mondo naturale risulta possibile, a determinate e rare condizioni, che un chicco d’orzo si trasformi in una pianta evitando di essere distrutto, notò Engels nel suo Anti-Dühring; in campo umano, a sua volta, delle potenzialità utili e indispensabili per il processo di costruzione di strumenti di produzione, quali la statura eretta e il pollice opponibile dei primi ominidi, si trasformarono in reali mezzi di produzione, i primi chopper e pietre scheggiate ad arte, dopo milioni di anni di latenza e di “incubazione” di tali possibilità. Una potenzialità che da astratta (con minime probabilità di affermarsi) diventò, in un dato momento, reale con un buon grado di probabilità di realizzazione e, infine, si trasformò in realtà oggettivata, come avvenne del resto in seguito per il sogno-potenzialità umana di volare, di esplorare altri corpi celesti e così via.[25]
Ennesima ricaduta di valore generale, la focalizzazione sull’interconnessione esistente tra progettualità, pratica e oggettivazione umana scoperta da Marx nei Manoscritti economico-filosofici del 1844, e riscoperta da Lukács agli inizi degli anni Trenta dello scorso secolo: con la derivata autocoscienza anche rispetto al lato negativo della pratica collettiva a partire dal feticismo, con il processo di auto-sottomissione dell’uomo ai suoi stessi prodotti, e dal processo di produzione di mezzi bellici.[26]
Fornendo infine un metodo generale per inquadrare e concepire le innumerevoli interconnessioni e trasformazioni dei multiformi fenomeni concreti, il materialismo dialettico mette a disposizione del sapere scientifico da più di un secolo quelle categorie astratte e quel processo di generalizzazione teoretico, ossia quella reale filosofia della scienza basata sui fatti che fin da Galileo Galilei costituisce la stessa condizione preliminare di esistenza di quest’ultima.[27]
Secondo un’altra diffusa obiezione, “non esiste la dialettica in natura, non si trova nel mondo naturale quella continua unità e lotta di forze opposte che rappresenta la presunta pietra filosofale del materialismo dialettico”.
Per quanto riguarda la legge dialettica della trasformazione della quantità in qualità, non è certo responsabilità di Karl Marx di aver semplicemente preso atto, nel nono capitolo del primo libro del Capitale, che, anche nel campo variegato delle «scienze naturali, si rivela la validità della legge scoperta da Hegel nella sua Logica, che mutamenti puramente quantitativi si risolvono a un certo punto in differenze qualitative».
La fusione nucleare, che avviene ogni nanosecondo da più di 13 miliardi di anni all’interno di una moltitudine di stelle e che la specie umana è ora in grado di riprodurre per circa 18 minuti (nel reattore cinese EAST, gennaio 2025), comporta a sua volta una reazione atomica: ad altissime temperature essa genera una particolare interazione tra la polarità dialettica di due nuclei di elementi leggeri quali di solito deuterio e trizio, innescando un salto di qualità nel quale si formano da un lato atomi più pesanti come l’elio e, dall’altro, viene emessa allo stesso tempo una grande quantità di energia.
Non è stata certo un’invenzione del “diabolico” Stalin quell’interconnessione generale tra il nulla e le particelle-antiparticelle virtuali, le quali si autodistruggono in tempi estremamente rapidi, che contraddistingue il vuoto quantistico: fenomeno universale confermato tra l’altro dall’effetto Casimir, testato da più di due decenni in tutto il globo.
Non è stato certo il tenebroso Stalin a inventarsi di sana pianta la concretissima e altrettanto universale connessione tra il bosone di Higgs e tutti gli oggetti del cosmo, con la quale la prima forza-campo conferisce la massa a questi ultimi.[28]
Non è certo responsabilità di Georges Politzer, filosofo comunista francese fucilato dai nazisti nel maggio del 1942, se Jo529-4351, l’oggetto più luminoso finora scoperto nell’universo, costituisce un buco nero con una massa pari a 17 miliardi di volte quella del Sole, e se esso cresce al ritmo di una massa solare al giorno: provando una volta di più, con il suo vorace processo di ingrandimento, che il cosmo risulta in continua mutazione, anche a causa dei buchi neri, la cui esistenza venne provata solo sei decenni or sono.
In relazione a tale argomento, va notato come le onde gravitazionali, capaci di alterare e trasformare parzialmente la stessa struttura spaziotemporale dell’universo, costituiscano, a partire dal 2015, un fenomeno indiscutibile e sottoposto a numerose verifiche empiriche.
Non solo nell’ultimo decennio sono state accertate numerose collisioni tra buchi neri e tra stelle di neutroni, scontri cosmici che producono le onde gravitazionali, ma inoltre sono state scoperte anche onde gravitazionali a bassa frequenza e operanti su scala assai maggiore di quelle per così dire “ordinarie”.
Aprendo sicuramente una rivoluzione nella futura astrofisica, le onde gravitazionali a bassa frequenza già ora dimostrano il processo di riproduzione di una quantità molto numerosa di superbuchi neri che, collocati al centro di gran parte delle galassie, si scontrano e si fondono carsicamente con altri buchi neri giganti relativamente vicini a loro, cambiando e modificando in parte – e meno male che non dovrebbe sussistere la dialettica nella natura – la stessa organizzazione spaziotemporale del cosmo.[29]
Le presunte e oscurissime trame filosofico-politiche di Stalin non c’entrano in alcun modo con il fenomeno generale, ormai dimostrato da più di un secolo, secondo il quale la luce e il fotone costituiscono un oggetto allo stesso tempo di natura sia corpuscolare che ondulatoria.
Per sventura e disgrazia dei nemici della dialettica della natura, il plasma, ossia lo stato della materia più diffuso nell’universo, è composto a sua volta dall’interazione reciproca, dall’unione e lotta simultanea di particelle con cariche positive e particelle con cariche negative, le quali tendono ad avere energie cinetiche simili.
Non è certo colpa del creativo materialismo dialettico se i poli elettromagnetici si rivelano altresì uno di carica positiva, l’altro invece di natura negativa; se, nelle stelle, la forza centripeta della gravità lotta, in ogni microsecondo, contro la tendenza centrifuga viceversa indotta dai processi di fusione nucleare; e ancora, se i processi chimici sono contraddistinti continuamente da unità di associazioni e dissociazioni degli atomi.
Oppure se gli organismi viventi sono segnati, allo stesso tempo, da tendenze opposte: ad esempio l’eredità genetica ma anche la mutazione (spesso minimale) del genoma, i processi di eccitazione o inibizione degli stimoli nella corteccia celebrale e quelli di simultanea concentrazione e diffusione di questi ultimi.
Gli esempi e le prove concrete possono essere facilmente moltiplicati, come ad esempio mediante il principio di azione e reazione nel settore scientifico della meccanica e attraverso il principio universale di sovrapposizione in campo quantistico.
In modo solo parzialmente simile alla dialettica estesa su scala cosmica tra onda e particella per i fotoni, all’interno dello sconfinato sub-universo materiale di matrice quantistica vigente funziona altresì il principio di sovrapposizione: esso prevede e indica che in un sistema quantistico possono essere sommati due o più stati quantistici contemporaneamente, nello stesso istante e microistante.
Si tratta di un principio universale di sovrapposizione che viene tra l’altro utilizzato e comprovato concretamente, ormai da decenni, dalla praxis collettiva umana all’interno del processo di costruzione e utilizzo dei computer quantistici, con un sistema binario di calcolo nel quale zero risulta allo stesso tempo uno, nello stesso istante e microistante.[30]
Per quanto riguarda poi l’ampio materiale empirico a sostegno della dinamica, continua e generale, di trasformazione di qualsiasi ente naturale, cosmo incluso, basta sottolineare che, se per alcuni anni persino il geniale Albert Einstein ritenne erroneamente che l’universo risultasse stazionario, tutta una serie di osservazioni astrofisiche dell’ultimo secolo hanno invece dimostrato come non solo l’universo si stia espandendo senza sosta e in ogni nanosecondo, ma che altresì tale processo globale di ingrandimento sta accelerando a sua volta.
Aveva dunque completamente torto, come del resto molti altri filosofi, anche il Lukács del 1923 e del libro Storia e coscienza di classe quando negò decisamente l’esistenza, oggettiva e indipendente dalla presenza/osservazione del genere umano, della dialettica della natura: dialettica della natura che il processo di sviluppo della scienza contemporanea conferma altresì anche per la legge generale dell’interconnessione tra tutte le cose e tra tutti i gradi di organizzazione della materia, come ad esempio viene attestato anche dalla dinamica di entanglement a livello quantistico.[31]
Il marxista Karl Korsch aveva sostenuto più di un secolo fa e in un suo libro del 1923, dal titolo Marxismo e filosofia, che il pensiero marxiano e marxista aveva come suo “obiettivo finale la soppressione della filosofia”, l’eliminazione di qualunque forma di filosofia.[32]
Come molti altri prima e dopo di lui, Korsch aveva fatto finta di dimenticare che Marx espresse in modo chiarissimo, anche nel sopracitato poscritto del 1873, la sua precisa presa scelta di campo filosofico sia a favore del materialismo che della dialettica, fra l’altro citando più volte Hegel.
Un silenzio assordante quello di Korsch, oltre che un voluto e intenzionale travisamento del pensiero dello stesso Marx: ma possiamo anche valutare con un’ampia prospettiva storica i miseri risultati del pensiero di Korsch, esaminando le tesi da lui stesso elaborate alla fine della sua esistenza.
Avendo infatti amputato ed eliminato, tra l’altro per via filosofica, la parte importantissima e squisitamente filosofica del marxismo avente per oggetto la visione del mondo e il metodo generale per interpretarlo e trasformarlo, a partire dalla metà degli anni Quaranta dello scorso secolo Korsch passò quasi inevitabilmente a ridurre praticamente a zero il ruolo del marxismo anche nel suo aspetto di scienza delle lotte di classe e delle rivoluzioni proletarie.[33]
Nel suo esilio statunitense, infatti, l’ex-estremista di sinistra degli anni Venti di nome Karl Korsch scrisse nel 1951 e in piena epoca maccartista il saggio intitolato Crisi del marxismo, nel quale egli affermò che «il marxismo come fenomeno storico che è sorto nei suoi tratti fondamentali innanzitutto nella lotta rivoluzionaria della prima metà del XIX secolo, […] questo marxismo è oggi un fatto del passato».[34]
“È oggi un fatto del passato”.
Quanti ex-marxisti hanno affermato questa frase prima e dopo Korsch, il quale, tuttavia, nel suo scritto intitolato Hegel e la rivoluzione fu almeno costretto ad ammettere, autodemolendo le proprie posizioni del passato sul marxismo come presunto artefice della soppressione della filosofia, che invece era realmente avvenuto «il salvataggio, fatto da Marx ed Engels, […] della dialettica cosciente della filosofia idealistica tedesca nella concezione materialistica della natura e della storia».[35]
Anche se diede un giudizio molto negativo rispetto a tale indiscutibile “salvataggio fatto da Marx e Engels” rispetto alla dialettica e al materialismo, Korsch ristabilì quindi la verità storica almeno in questo campo della filosofia e, simultaneamente, con un funerale di quarta classe, autodistrusse proprio le sue precedenti tesi sul marxismo da intendersi come antifilosofia.
Il filosofo francese Michael Foucault indicò chiaramente, nel suo saggio di epistemologia pubblicato nel 1969 con il titolo L’archeologia del sapere, che non è la realtà materiale l’elemento prioritario e centrale rispetto allo spirito, alla coscienza e alle idee, ma viceversa è la parola, è il “discorso” a plasmare e via via a creare/ricreare la realtà materiale sulla quale esso parla e che descrive, come nel caso esemplare per il filosofo francese della pazzia e della “malattia mentale”.[36]
La vera malattia mental-filosofica è costituita dall’idealismo soggettivo, di cui Foucault si fece portatore con forme attenuate e che ben corrisponde ad un universo alternativo descritto in un racconto dello scrittore argentino J. L. Borges, su cui torneremo.
La realtà risulta molto diversa da quella mal dipinta e deformata da parte di Foucault. Ad esempio, la neuroscienza ha dimostrato, fin dalla genesi delle prime strutture cerebrali negli animali più di cinquecento milioni di anni fa, che anche i cervelli più elementari come quelli delle meduse possiedono la neuroplasticità: ossia la capacità dei neuroni e delle sinapsi di cambiare le loro stesse strutture e funzioni in risposta sia alle esperienze che agli stimoli provenienti dal mondo esterno, arrivando nel caso concreto delle meduse a prevedere la direzione del vento.[37]
Non è stato dunque il “discorso” alla Foucault a plasmare il cervello delle meduse, oppure quello dei meravigliosi homo habilis che iniziarono a costruire sistematicamente le prime pietre scheggiate ad arte: ma invece la pratica in continuo contatto con un mondo esterno (Terra, Sole, Via Lattea, ecc.) che si riproduce indipendentemente dalla nostra esistenza, in modo totalmente autonomo dalle favole propinate da filosofi idealisti del tipo di Foucault.
Praxis interconnessa con la realtà esterna che spiega, tra l’altro, la formazione della neuroplasticità animale e umana, dimostrando la falsità delle ormai vecchie e superate teorie che valutavano il cervello come una struttura immobile e, viceversa, verificando e confermando sulla base di molteplici dati scientifici la sopracitata tesi filosofica, di valore generale, espressa da Marx nel gennaio del 1873. Secondo quest’ultima la dialettica “nella comprensione positiva dello stato di cose esistente include simultaneamente anche la comprensione del suo necessario tramonto perché concepisce ogni forma divenuta” (quindi anche le strutture cerebrali estremamente diverse delle meduse e degli esseri umani) “nel fluire del movimento, quindi anche dal suo lato transeunte”: ossia, anche dal lato e dall’aspetto del continuo processo di trasformazione di ogni ente naturale, ivi compresi i cervelli delle meduse e degli ominidi.
“Anche Gustavo Wetter mosse una serie di critiche al materialismo dialettico”.
Citando Marx[38], afferma che «l’“unità essenziale” di uomo e natura – intravista da Marx – dovrebbe essere posta sulla base dell’unità non solo ontologica delle due, ma anche temporale», attaccando così l’elemento essenziale del materialismo, ossia il fatto che la materia preceda l’uomo.
E, infatti, continua attaccando (come ci si poteva aspettare) Engels, definito “il vero capostipite” del materialismo dialettico. Critica Engels per la polemica che egli conduce contro Hegel, protestando che quegli non ha “compreso” ciò che questi avesse scritto e che quindi il famoso “rovesciamento” della dialettica idealista in quella materialista non fosse un vero e proprio opposto. Quindi il Wetter pretende lui di dettare a Engels come “rovesciare” e che chi “rovescia” deve dire tutto al contrario, e non qualcosa sì e qualcosa no.[39]
Anche con Lenin, Wetter non è leggero. «Lenin non intende materia semplicemente nel senso di realtà oggettiva, ma nel senso della realtà oggettiva che ci è data nelle sensazioni; e questa è soltanto una realtà materiale». Purtroppo, è proprio la dialettica che sfugge a Wetter. Si abbarbica a una polemica che andrebbe forse a segno se fosse rivolta a Kant, ma non a chi ha precisato la natura dialettica tra la realtà materiale esterna e il riflesso nel pensiero umano. Tra l’altro, il Wetter trascura proprio la polemica che Lenin fece contro chi voleva cambiare la definizione di “materialismo” in “realismo”, proprio a causa dell’equivocità di quella definizione che scivola facilmente nel fenomenismo positivistico.
Poi con Stalin afferma: «L’unica variante che Stalin introdusse nella dottrina sovietica fu l’eliminazione della legge della negazione della negazione». Cioè non capisce che “la quarta la legge dell’unità e della lotta degli opposti” è la proposizione in termini più moderni proprio di quella legge. Quanto poi Wetter abbia letto Stalin si deduce da questa affermazione: «Stalin risolse il problema delle nuove forze propulsive per l’evoluzione sociale sostituendo alla lotta di classe quattro nuove forze propulsive». Stalin: «Nello stadio attuale di sviluppo e dati gli attuali rapporti di forza, si producono l’inasprimento della lotta di classe e la resistenza più intensa degli elementi capitalistici della città e della campagna».[40] Ma il concetto di “nello stadio attuale” non rientra nella logica di Wetter. Fu invece Chruščëv a dichiarare la fine della lotta di classe in URSS.
Il punto filosofico essenziale però è qui[41]: la ripulsa della costatazione di cui la scienza e tutti noi nella nostra vita quotidiana facciamo esperienza, che i processi procedono per salti, per accumulazioni. L’argomentazione riproduce formalmente quella di Achille e la tartaruga, l’impossibilità di spiegare il movimento perché esso dovrebbe essere costituito da infiniti infinitesimi progressi che poi si accumulano. Diogene di Sinope ci indica la strada. Fai, e ti accorgerai che le “ubbie” dei “metafisici” spariscono come gli incubi al mattino.
Inoltre,[42] si impone la categoria del “perché” ai processi naturali, senza specificarne la limitazione, imponendo al significato un contenuto teleologico per cui non può non esserci un “disegno” esterno e prioritario. È chiaro che nella capziosa premessa starebbe l’inevitabile risposta. Siamo ancora alla prova ontologica di dio. Kant, per favore, aiutami tu e fammi trovare i cento talleri nella mia tasca![43]
Quanto al criterio principe del materialismo dialettico, che è la prassi,[44] si torna a un idealismo soggettivo che ci riporta a Berkley, al Cardinale Bellarmino, a chi svaluta per principio, questo sì indimostrato, l’attività del pensiero umano. La verità deriva dalla Rivelazione, il resto è apparenza.
Sulla concezione materialistica della storia si comincia con una sviolinata riconoscendo «gli elementi positivi contenuti in questa dottrina, che costituiscono un merito imperituro di Marx», ma, attenzione!, limitatamente al «cogliere tutta la drammaticità delle condizioni sociali del suo tempo». Quindi un Marx iscritto d’ufficio alla Caritas.
Saltiamo la confusione che fa su struttura e sovrastruttura e andiamo alla lotta di classe. Che poi è la ciccia di ogni discorso. Alla fine, è la forza dei lavoratori coscienti e organizzati che si deve sterilizzare. Naturalmente non può mancare l’accusa al «determinismo storico che inerisce a tutto il materialismo storico» e al mancato crollo previsto del capitalismo, parlando invece di «un’attenuazione della lotta di classe». E meno male che c’è stata un’attenuazione, altrimenti il socialismo avrebbe trionfato in tutto il mondo!
Chicca finale: «È particolarmente significativo il fatto che questa emancipazione del proletariato divenne possibile grazie proprio alla democrazia politica. È questa la migliore confutazione della teoria comunista dello Stato e del diritto».
Che queste conquiste siano state ottenute attraverso lotte immani dei lavoratori, guidati per lo più dalla teoria marxista, non turba Wetter.
In conclusione, un miscuglio di abusati luoghi comuni sul marxismo, critiche al materialismo sol perché esso non collima con quello che lui pretende che esso sia, incapacità a capire o ad accettare le leggi basilari della dialettica e all’emergentismo che spazza via tutta la metafisica, sovvertimento della realtà storica della prima metà del XX secolo in cui il testo è stato scritto.
Un’ulteriore critica ha avuto per oggetto il presunto carattere monolitico e statico assunto dalla filosofia materialistica e dialettica, a partire almeno dalla morte di Lenin.
Rispetto all’immaginario monolitismo del marxismo in campo filosofico dopo il 1923-24, è sufficiente un breve confronto del testo di Stalin Materialismo dialettico e materialismo storico del 1938 con il libro di H. Lefebvre del 1947, intitolato Il materialismo dialettico, per comprendere la varietà di visioni e approcci presenti anche in quegli anni tormentosi all’interno del materialismo dialettico.[45]
Riguardo, invece, alla supposta stagnazione secolare del materialismo dialettico, persino una rapida e superficiale lettura indica e garantisce il superiore livello di sofisticazione e profondità (la categoria di campo nella filosofia e nella scienza, ecc.) del manuale del 1981 di V. Afanas’ev, intitolato Fondamenti di filosofia marxista-leninista, rispetto a quello pubblicato invece in precedenza e nel 1970 da A. Šeptulin, con il titolo La filosofia marxista-leninista.[46]
Inoltre, di recente, Vanna Melia e Alessandro Pascale hanno rilevato come le leggi generali della dialettica enucleate da Stalin nel 1938 risultassero quattro, e non tre come invece indicato da Engels in questo campo specifico seguendo la scia di Hegel.[47]
Siamo in presenza di un ben strano immobilismo e stagnazione di matrice analitica, non c’è che dire…
“La filosofia marxista non fornisce comunque niente di rilevante e interessante per la vita quotidiana degli esseri umani”.
Avere una prospettiva cosmica fra l’altro almeno potenzialmente in grado di riprodursi, superato il collo di bottiglia della guerra nucleare, per miliardi di anni serve e aiuta anche “nei giorni che passano pigri”, per dirla con il creativo Gino Paoli.
Avere individuato un soggetto collettivo di riferimento potenzialmente eterno come il genere umano, attraverso la futura terraformazione di nuovi pianeti, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, la costruzione di un nuovo livello di cyborg e così via non rende certo nichilisti e pessimisti in via di principio.
Acquisire poi un fine supremo, di specie e individuale, quale lo sviluppo delle capacità e delle conoscenze di qualunque tipo, a partire dall’apparentemente semplice processo di respirazione, esclude la tentazione biblica del “tutto è vanità”.
Poter inoltre contare e pesare anche come semplici individui nel processo storico, visto che la storia siamo noi (seppur con i nostri limiti e lati negativi), esalta il ruolo potenziale di ciascun essere umano.
Avere, infine, la chiave sia per risolvere i principali interrogativi sui quali si arrovella da millenni il processo di riflessione umano (che tipo di mondo ci circonda? Esiste dio? Qual è il ruolo dell’uomo nel cosmo, e così via) sia per assaporare e intendere le meraviglie fornite dalle continue nuove scoperte, nel campo delle scienze naturali e sociali, rappresenta un tesoro spirituale che consente di ridurre al minimo il livello di quella “disperazione”, non solo inglese, di cui parlava il filosofo e geniale musicista Roger Waters osservando, nel 1973, il lato oscuro della Luna in un celeberrimo disco dei Pink Floyd.
“Come hanno sostenuto filosofi neopositivisti quali R. Carnap e B. Russell, il quesito sulla priorità tra la materia e lo spirito costituisce solo uno pseudoproblema, privo di qualsiasi significato per la riflessione filosofica”.
Anche ammettendo per un attimo che la questione relativa all’esistenza/inesistenza di dio e delle divinità – che deriva e discende inevitabilmente dalla sopracitata domanda fondamentale della filosofia – sia solamente uno pseudoproblema, senza risolvere l’enigma del primato temporale e ontologico della materia o della coscienza diventa impossibile anche fornire un valido metodo generale di analisi dei dati scientifici, oltre che di quell’aspetto semantico delle parole, delle proposizioni e della struttura grammaticale che stava e sta tuttora molto a cuore alla corrente teorica del neopositivismo, nelle sue diverse sfaccettature.
Infatti il processo di esame dei dati scientifici presuppone, necessariamente e prima di tutto, che venga chiarito in via preliminare almeno se questi ultimi costituiscano il risultato del riflesso della concreta e oggettiva realtà, nei suoi multiformi lati e interconnessioni, nel pensiero e nel cervello dei ricercatori, oppure se tali informazioni rappresentino invece il frutto e il sottoprodotto prodotto principale dell’attività creativa della coscienza, della praxis degli scienziati e/o degli esperti di logica e semiologia.
Si tratta di un vero e proprio essere o non essere sotto vesti filosofiche, dunque: e non risulta certo un caso che Carnap e Russell fossero inclini e favorevoli alla seconda ipotesi, ad attribuire, cioè, un carattere decisivo al processo creativo umano sia per quanto riguarda le informazioni scientifiche che il senso e il significato delle parole e del linguaggio.[48]
Siamo in presenza di un basso livello nel processo di elaborazione teorico, che assieme all’acqua sporca (la metafisica, l’idealismo oggettivo e soggettivo) butta via anche il bambino, e cioè la stessa filosofia che, sia detto di sfuggita, nel mondo occidentale si genera come ontologia, analisi del principio ed essenza delle cose.
Anche un pensatore in parte vicino alla scuola neopositivista come Ludwig Wittgenstein (1889-1951), assai lucido e sofisticato, rispetto al mondo e alla realtà all’inizio del suo Tractatus logico-philosophicus non seppe affermare altro, nel 1921, se non che il mondo è la totalità dei fatti o, meglio, la totalità dei fatti atomici (detti stato di cose), cioè dei fatti che accadono indipendentemente l’uno dall’altro, sostenendo addirittura che ai tempi moderni dominasse “l’illusione che le cosiddette leggi naturali siano le spiegazioni dei fenomeni naturali” (Tractatus, 6.371).
Ora, purtroppo, per la tesi basilare di Wittgenstein l’universo, il cosmo, il mondo è composto non solo da “fatti” – in effetti enti e cose naturali – interconnessi in modo indissolubile l’uno con l’altro, come dimostra l’azione omnipervasiva della forza di gravità, del bosone di Higgs e dell’entanglement quantistico, per citare solo alcuni esempi, ma l’universo risulta altresì distinto in livelli di organizzazione della materia che vanno dai superammassi galattici al vuoto quantistico: livelli diversi tra loro ma, allo stesso tempo, strettamente collegati e interconnessi.
“Il materialismo dialettico non è scientifico perché non è falsificato dall’avverarsi/non avverarsi delle sue previsioni in base all’esperienza, come sostenne circa un secolo fa Karl Popper”.
Il falsificazionismo di Popper si rivela innanzitutto una teoria epistemologica che si falsifica da sola e per conto suo, visto che deve ammettere che tutte le teorie e tesi scientifiche vengono confermate e “corroborate” (Popper) dai fatti e dagli esperimenti concreti, non certo dalle falsificazioni: e tutto ciò risulta chiaro analizzando il concreto processo di sviluppo delle scienze naturali dai tempi di Galileo Galilei, quattro secoli fa.
Popper cercò di salvare la sua tesi notando altresì che, anche se una teoria ha superato le prove di verifica del passato, nulla garantisce sulla sua affidabilità e idoneità a superare e a sopravvivere ai controlli scientifici futuri.
Ma anche questa tesi di Popper viene falsificata dai fatti concreti, perché neanche un solo esempio concreto la corrobora e la conferma, con casi di teorie scientifiche provate da continue verifiche sperimentali dopo Galileo ma, in seguito, invece divenute e ritenute unanimemente errate davanti alla comunità scientifica internazionale?[49]
Neanche un esempio, a favore di questa sezione del popperismo: ma il materialismo dialettico davvero effettua previsioni realmente verificabili dalla pratica?
Certo.
A tale scopo mettiamo subito a confronto Marx ed Einstein, riguardo alle loro rispettive analisi e predizioni sulla natura e sul futuro dell’universo.
Si è già notato che Marx, nel gennaio del 1873, scrisse che la sua dialettica materialistica concepiva «ogni forma divenuta», quindi anche tutto il cosmo e l’intero universo, «nel fluire del movimento, quindi anche nel suo lato transeunte»: quindi in via di trasformazione, quindi un cosmo in continuo movimento e cambiamento.
Einstein invece, dal 1916 e per lunghi anni, sostenne la visione di un universo statico, non in espansione. Al fine di dimostrare questa visione, Einstein introdusse, nel febbraio del 1917, la “costante cosmologica” all’interno della sua “equazione di campo”; tale costante era intesa rappresentare una forza contraria alla gravità, che spiegasse quindi come mai la materia non tendesse a ricompattarsi in un tutt’uno in base alle leggi di Newton.
Con grande onestà, proprio lo stesso Einstein definì la sua cosmovisione filosofico-scientifica come “il più grande errore della sua vita”, rinnegando la “costante cosmologica”: le verifiche successive, infatti, corroborano, per dirla alla Popper, la visione di un universo in continuo cambiamento e più precisamente in un moto di espansione accelerata, di un accelerato “fluire del movimento”, per usare la terminologia del Marx del 1873.[50] Paradossalmente, gli scienziati hanno successivamente rivalutato la “costante cosmologica” di Einstein, oggi utilizzata per spiegare l’accelerazione dell’espansione dell’universo, il che significa che il grande fisico aveva realizzato un calcolo corretto dal punto di vista prettamente scientifico-matematico, dandone tuttavia un’interpretazione errata, almeno fino alla sua revisione della teoria nel 1930.
Anche la legge generale della dialettica sull’interconnessione universale tra tutti gli enti e i processi naturali ha avuto numerose verifiche empiriche (entanglement quantistico, forza della gravità operante anche negli ammassi galattici, ecc.), come del resto è successo per le leggi universali dell’unità-lotta tra poli opposti e dei salti di qualità una volta raggiunta una determinata fase di accumulazione quantitativa.
Tanti fatti corroboranti, certo, i quali simultaneamente confutano e falsificano (ma non fatelo sapere ai seguaci di Popper, per carità) le teorie di cosmovisione antagoniste rispetto a quelle del materialismo dialettico.
In ogni caso il geniale, anche se non infallibile, Albert Einstein aiutò involontariamente la cosmovisione marxista devastando le teorie gnoseologiche del fisico e filosofo Ernst Mach, agli inizi del Novecento un punto di riferimento teorico per lo stesso Einstein.
Mach non solo sosteneva la tesi secondo cui non poteva sussistere alcun oggetto senza soggetto, ma proprio partendo da essa, nel gennaio del 1897, affermò pubblicamente che “non credo che esistano gli atomi”: e, del resto, non essendo gli atomi delle particelle tangibili e (ancora) osservabili dalla soggettività umana, risultava dunque logico che Mach, convinto che gli oggetti della scienza non fossero entità reali se indipendenti dall’esperienza, non prestasse fede all’esistenza degli atomi.[51]
Fu proprio Einstein, un estimatore in campo scientifico e filosofico di Mach, a dimostrare che quest’ultimo aveva completamente sbagliato.
Esaminando infatti il fenomeno del moto browniano, scoperto da Robert Brown nel 1827 osservando al microscopio dei granelli di polline immersi in un fluido che si muovevano in modo irregolare in tutte le direzioni, Einstein dimostrò che tale moto disordinato e disomogeneo dei granelli indicava come l’acqua fosse composta da un numero infinito di particelle con movimento casuale, e cioè gli atomi.
Quindi addio, signor Mach.
Quindi addio alla teoria dell’inesistenza degli atomi.
E addio anche alla tesi secondo cui non esisteva alcun oggetto senza soggetto umano, visto che i concretissimi e realissimi atomi furono per la prima volta osservati al microscopio da uno scienziato solo nel 1955.
Ma non solo.
Il fedele compagno di Marx, Friedrich Engels, scrivendo due opere filosofiche quali L’AntiDühring e la Dialettica della natura ha evidenziato, in pieno accordo con Marx, che la natura ha una sua storicità ed è capace di produrre salti di qualità, nuovi livelli di organizzazione e novità: in sostanza, Engels fu uno dei principali precursori del moderno emergentismo, accettato ormai da larga parte della scienza contemporanea, ivi compresa la neuroscienza.
Non a caso, sulla rivista Monthly Review, Kaan Kangal ha sottolineato, alla fine del 2020, che:
«Ad esempio, lo storico polacco Zbigniew A. Jordan ha sostenuto con forza che l’idea centrale dell’evoluzione emergente si trova nell’AntiDühring e nella Dialettica della natura». Secondo la dialettica emergentista di Engels, «la realtà materiale ha una struttura multilivello; ognuno di questi livelli è caratterizzato da un insieme di proprietà distintive e leggi irriducibili; e ogni livello è emerso da livelli temporalmente precedenti secondo leggi che sono assolutamente imprevedibili rispetto a quelle operanti ai livelli inferiori». L’idea di emergenza è intimamente legata alla concezione di Engels della dialettica come scienza delle interconnessioni tra sistemi coesistenti e interdipendenti di corpi fisici. La famosa affermazione di Engels secondo cui il movimento è il modo di esistenza della materia suggerisce che la materia abbia il potere di generare novità e diversità in natura. Il principio secondo cui «la materia è capace di creare novità e di produrre forme di organizzazione sempre più elevate è parte integrante del materialismo dialettico fin dalla sua prima formulazione da parte di Engels». Come ha opportunamente formulato il matematico e filosofo scozzese Hyman Levy, l’idea dialettica dell’evoluzione suggerisce che «forme complesse di materia animale e vegetale vivente sono emerse da forme più semplici che si collegano attraverso innumerevoli ere fino a forme sempre più elementari».
Anche Bunge condivide la convinzione che «il materialismo dialettico abbia il merito di enfatizzare la novità qualitativa, o emergenza», o ciò che Mayr chiamava «una gerarchia di livelli di organizzazione, a ciascuno dei quali può essere all’opera un diverso insieme di processi dialettici». Poiché diversi livelli di complessità del movimento costituiscono una gerarchia di livelli di organizzazione della materia, come osserva Ted Benton, la natura deve essere considerata un’unità gerarchicamente ordinata e internamente differenziata. È questa unità che si configura come precondizione per la convergenza di singole scienze. La conoscenza unificata della natura presuppone un’unità interconnessa di sviluppo storico differenziato e disomogeneo di scienze distinte. “Il dominio della natura di cui ogni scienza si occupa rappresenta non solo un distinto livello di complessità del movimento, ma anche una fase definita nell’evoluzione storica dell’universo”.
In altre parole, è la storicità della natura, così come il progresso continuo di singole scienze, a rendere necessaria una revisione critica del nostro quadro di riferimento scientifico. Esiste sempre un’esigenza interna alla teoria di esaminare rigorosamente l’apparato concettuale in uso. Ciò implica anche una continua integrazione delle novità emerse e scoperte nel nostro attuale corpus di pensiero. Pertanto, non sorprende che la dialettica di Engels si concentri principalmente sulle interconnessioni in evoluzione e sulle novità emergenti in natura. Analogamente, Engels definisce la dialettica come l’indagine sistematica delle interconnessioni universali in natura: «È proprio la dialettica a costituire la forma di pensiero più importante per le scienze naturali odierne, poiché essa sola offre l’analogo, e quindi il metodo per spiegare, i processi evolutivi che si verificano in natura, le interconnessioni in generale e le transizioni da un campo di indagine all’altro».
Nel cogliere le qualità e le leggi emergenti sui vari livelli di organizzazione della materia, la teoria dialettica impiega la propria struttura concettuale, il proprio linguaggio scientifico e il proprio metodo di indagine, e assume una forma categorialmente aperta.
In un passaggio in cui Engels discute alcuni criteri per distinguere e classificare diverse discipline scientifiche, egli sottolinea che ciascuna scienza si occupa di una specifica forma di movimento, peculiare del terreno corrispondente. L’oggetto dell’analisi potrebbe essere «una singola forma di movimento o una serie di forme di movimento che si compenetrano e si trasformano l’una nell’altra». Il punto è che tale classificazione deve seguire la disposizione oggettiva e la sequenza evolutiva intrinseca delle forme di movimento in questione. Va da sé che la ricostruzione logico-ontologica della sequenza degli eventi naturali debba assumere, di conseguenza, una forma sistematica. «Se definisco innanzitutto fisica la meccanica delle molecole, chimica la fisica degli atomi e, inoltre, biologia la chimica delle proteine, desidero esprimere con ciò il passaggio di ciascuna di queste scienze nell’altra, quindi sia la connessione, la continuità, sia la distinzione, la separazione discreta».
Quando il mondo organico si sviluppa da quello inorganico, sviluppa forme specifiche di movimento e leggi proprie. Ciò che storicamente precede lo sviluppo del mondo organico, ovvero l’inorganico, continua a vivere in una forma “sublimata”. Eppure, il mondo organico è evidentemente diverso da quello inorganico. Il suo sistema possiede molte proprietà emergenti mai riscontrate nel mondo inorganico. Soprattutto, i modelli comportamentali dei sistemi organici sono governati dai loro programmi genetici, che contengono informazioni acquisite storicamente.
In questo contesto, Engels fornisce un’illustrazione notevole che non solo sostiene l’interconnessione e l’interpenetrazione di sfere distinte come la chimica e la biologia, ma si basa anche su una proprietà emergente che oggi è chiamata autopoiesi, una caratteristica generativa dei sistemi auto-organizzati:
«Nel mondo organico… tutte le indagini chimiche conducono in ultima analisi a un corpo – la proteina – che, pur essendo il risultato di ordinari processi chimici, si distingue da tutti gli altri per essere un processo chimico permanente e auto-attivo. Se la chimica riesce a preparare questa proteina, nella forma specifica in cui è ovviamente sorta, quella di un cosiddetto protoplasma, una specificità, o meglio un’assenza di specificità, tale da contenere potenzialmente in sé tutte le altre forme di proteina…, allora la transizione dialettica sarà stata dimostrata nella realtà, quindi completamente dimostrata».
La dialettica emergentista difende la visione di un “continuo aumento del livello di organizzazione” e della complessità dei meccanismi sistemici in natura. La successione di ciascun livello dipende dalle circostanze materiali che determinano il fiorire delle sue proprietà emergenti, che sono necessariamente uniche rispetto ai livelli di complessità precedenti. Provvisoriamente, i diversi livelli possono essere distinti l’uno dall’altro per mezzo delle rispettive componenti. Ma sono opportunamente differenziati se si considerano l’interrelazione e l’organizzazione interna delle parti. I quark si combinano per formare adroni come protoni e neutroni, che a loro volta formano atomi, che costituiscono molecole, le quali a loro volta costruiscono costituenti cellulari e particelle colloidali; gli aggregati colloidali danno origine a tessuti e cellule viventi, e le cellule a organi e sistemi di organi, e così via».[52]
In ogni caso, come si è già mostrato più volte in precedenza, risulta ormai impossibile descrivere l’universo e le principali scoperte avvenute nel campo della fisica dopo il 1900, con la formidabile spinta d’avvio effettuata da Planck ed Einstein, senza l’utilizzo della categoria chiave e di matrice marxiana della contraddizione, dell’unità e lotta di tendenze opposte in ogni fenomeno naturale.
Ad esempio, la scienza ha riconosciuto negli ultimi decenni che il vuoto quantistico è composto di nulla e, simultaneamente, di particelle e antiparticelle virtuali che si autodistruggono in tempi iper-rapidi.
Inoltre, viene dato per assodato da alcuni anni che qualunque oggetto, dai quark alle galassie, è formato da sé stesso ma, simultaneamente, anche dal campo e dal bosone di Higgs, che conferisce a ciascuno di loro massa e consistenza.
Ancora, i quark, le particelle fondamentali che compongono la materia, non si manifestano mai da soli ma sempre in combinazioni variabili fra di loro.
Sussiste poi un collegamento dialettico tra massa ed energia, dimostrato a partire dalla celeberrima equazione di Einstein secondo cui E = mc2.
Anche il legame dialettico tra massa/energia e curvatura dello spazio è ormai da tempo emerso e convalidato anche alla luce della teoria generale di Einstein: quindi più massa equivale a una maggiore curvatura dello spazio circostante.
Su scala cosmica, inoltre, gli elementi radioattivi coesistono con quelli invece non radioattivi, dotati di un nucleo stabile per tempi a volte di enorme durata.
Anche l’interazione continua tra la materia oscura e l’energia oscura da un lato, e la materia per così dire normale costituisce da circa tre decenni una delle novità più clamorose in campo astrofisico, in un quadro generale nel quale la materia e l’energia oscura formano ben il 95% dell’intero cosmo.
Anche la dinamica di unione tra le galassie negli ammassi di galassie, tramite un processo di attrito gravitazionale denominato attrito di Chandrasekhar, è connessa dall’opposto e simultaneo processo di allontanamento tra le galassie nei grandi complessi formati da quest’ultime: distacco dovuto principalmente alla continua espansione dell’universo.
In ogni stella agiscono sia la tendenza centripeta, con la pressione esercitata dalla forza di gravità, che simultaneamente, la controtendenza costituita dalla fusione nucleare, la quale equilibra la forza di gravità e impedisce quindi alla stella di collassare.
All’interno di ogni buco nero la massa iperdensa al suo interno convive costantemente con le leggi della quantistica, in base alle quali le fluttuazioni quantistiche nel buco nero determinano l’emissione di particelle in questi ultimi: si tratta della radiazione di Hawking.
La luce, a sua volta, mostra un dualismo tra onda e particella, comportandosi a volte come un’onda elettromagnetica e a volte, invece, come un flusso di particelle denominate fotoni.
Almeno in particolarissime condizioni, raramente e per brevissimo tempo, nel nostro universo si ritrova inoltre l’antimateria, nei raggi cosmici e nei processi di decadimento di alcune sostanze radioattive: antimateria che viene distrutta entrando in contatto con la materia ordinaria.
A livello atomico, poi, gli elettroni hanno carica elettrica negativa mentre i protoni del nucleo viceversa possiedono una carica elettrica positiva.
Per quanto riguarda poi la questione del tempo, da millenni un vero e proprio incubo e un problema insolubile per la filosofia di matrice idealistica, la teoria generale della relatività e innumerevoli esperimenti scientifici avvenuti nel corso dell’ultimo secolo supportano ormai in modo indiscutibile la tesi materialistica secondo la quale il tempo costituisce una delle dimensioni e delle proprietà fondamentali della materia in movimento.
Proprio Einstein, supportato da molteplici forme di osservazione scientifica, ha dimostrato che il tempo non è assoluto ma, viceversa, è relativo e strettamente connesso al livello di movimento di qualsiasi ente naturale. Quando un oggetto, ad esempio, si muove ad una velocità prossima a quella della luce, il tempo rallenta significativamente per gli osservatori e gli oggetti in movimento iper-accelerato rispetto a quelli invece relativamente fermi, fenomeno che va associato in forme diverse a quello della dilatazione temporale gravitazionale sperimentato anche sulle stazioni spaziali orbitanti attorno al nostro pianeta.[53]
Sul fronte dell’antimaterialismo filosofico, invece, un testimone insospettabile come Borges ha mostrato che una serie di filosofi avevano negato, sotto varie forme, l’esistenza stessa del tempo inteso come successione tra presente, passato e futuro, partendo dal filosofo Sesto Empirico.
«Questi (Adversus Mathematicos, XI, 197) nega il passato, che è già stato, e il futuro, che non è ancora, e argomenta che il presente è divisibile o indivisibile. Non è indivisibile, giacché in tal caso non avrebbe un principio che lo leghi al passato né una fine che lo leghi al futuro, e neppure un centro, perché non ha centro ciò che manca di principio e di fine; non è neppure divisibile, giacché in tal caso consterebbe di una parte che è stata e di un’altra che non è. Ergo non esiste, ma poiché non esistono neanche il passato e il futuro, il tempo non esiste. F. H. Bradley riscopre e perfeziona questa alternativa. Osserva (Appearence and Reality, IV) che, se l’ora è divisibile in altri ora, non è meno complicato del tempo, e se è indivisibile, il tempo è una mera relazione tra le cose intemporali. Tali ragionamenti, come si vede, negano le parti per poi negare il tutto; io rifiuto il tutto per esaltare ciascuna delle parti. Attraverso la dialettica di Berkeley e di Hume sono arrivato all’opinione di Schopenhauer: “La forma dell’apparizione della volontà è solo il presente, non in passato né il futuro; questi non esistono se non per il concetto e per l’incatenamento della coscienza, sottoposta al principio di ragione. Nessuno ha vissuto nel passato, nessuno vivrà nel futuro: il presente è la forma di ogni vita, è un possesso che nessun male può strapparle… Il tempo è come un cerchio che giri infinitamente: l’arco che discende è il passato, quello che sale è il futuro; in alto, c’è un punto indivisibile che tocca la tangente ed è l’ora. Immobile come la tangente quel breve punto segna il contatto dell’oggetto, la cui forma è il tempo, con il soggetto, che manca di forma perché non appartiene al conoscibile è previa condizione della conoscenza» (Welt als Wille und Vorstellung, I, 54).
Un trattato buddhista del secolo quinto, il Visuddhimagga (Via della Purezza) illustra la stessa dottrina con la stessa figura: «A rigore, la vita di un essere dura quanto un’idea. Come la ruota di un carro, girando, tocca la terra in un solo punto, così la vita dura quel che dura una sola idea» (Radhakrishnan, Indian Philosophy, I, 373).[54]
Torniamo ora finalmente al mondo del pensiero razionale.
Come aveva indicato il più grande filosofo italiano della scienza, Ludovico Geymonat, dal Diciottesimo secolo in avanti «la ricorrenza di dicotomie come discreto/continuo, forze/campo, particelle/onde sembrano scoraggiare ogni tentativo di interpretazione realistica, e lasciarci esausti come dopo lo spettacolo di una lanterna magica. La risposta che ho tentato di dare è questa: per superare queste apparenze e cogliere dietro di esse una razionalità nella storia o, più in generale, nella natura, bisogna ricorrere a un’estensione di questa nozione e passare da una ragione puramente logico-formale a una ragione dialettica.
È solo nel senso di questa nozione estesa che siamo in grado di scoprire una trama nel mutamento scientifico”.[55]
Si potrebbe obiettare che, oltre a inquadrare e descrivere la dinamica strutturale del cosmo, le leggi generali della dialettica debbano anche svolgere una reale funzione predittiva su di essa.
Era stato proprio Karl Marx, il fondatore principale del materialismo dialettico, a evidenziare con forza nel gennaio del 1873 il ruolo estremamente positivo svolto dalla scoperta delle “forme generali di movimento” e delle leggi generali della dialettica, individuate da Hegel anche se sotto un “rivestimento mistico” (Marx, 1873) e utilizzate da Hegel a sostegno della sua teoria generale di matrice idealistico-oggettiva.
Anche su questo punto specifico, di grande valore teorico, Marx aveva ragione.
Partendo dalla legge della trasformazione universale, basata sull’unità e lotta di tendenze opposte in ogni fenomeno, essa indica che anche in futuro vi sarà, sotto forme diverse, l’interpenetrazione costante e generalizzata tra il vecchio e il nuovo, nuovo derivato inevitabilmente proprio dal cambiamento ininterrotto su scala cosmica.
Ad esempio la nuova fusione di due giganteschi buchi neri in un’unica entità con una massa pari a 225 volte quella del Sole, registrata nel luglio del 2025, simultaneamente aveva anche prodotto un’onda gravitazionale di eccezionale intensità e una quantità di energia pari a migliaia di miliardi di miliardi di volte a quella liberata da un ordigno nucleare: assieme alle circa duecento nuove onde gravitazionali scoperte dal 2015 a oggi, si tratta dell’ennesima conferma concreta del cambiamento continuo a livello universale.
A catena, poi, quest’ultimo consente anche di individuare il passato, il presente ma soprattutto il futuro intreccio indissolubile di poli opposti quali i processi di creazione e distruzione, formatisi via via inevitabilmente dalla legge dialettica in via di esame; dinamiche di generazione che avvengono anche su scala globale, quale quella osservata nell’ estate del 2025 dagli astrofisici cileni e di altri paesi studiando, senza soluzione di continuità ,le primissime fasi della nascita di una stella denominata HOPS- 315 e distante circa 1400 anni luce dalla Terra.[56]
Inoltre, la legge del mutamento universale indica anche per il futuro il processo costante di riproduzione della contraddizione tra continuità e trasformazione, presente in tutti gli enti materiali e in ogni istante della loro esistenza concreta, come sottolineato da Marx nel 1873: ad esempio in ogni secondo muoiono migliaia di cellule di qualunque essere umano vivente.
La dinamica del continuo cambiamento cosmico ha altresì preso da molti miliardi di anni la forma principale dell’espansione accelerata dell’universo, prefigurando che sia nel prossimo che nel più remoto futuro continuerà ad affermarsi al suo interno la dinamica generale dell’allontanamento crescente delle galassie le une dalle altre, con eccezioni dovute all’attrazione gravitazionale operante senza sosta all’interno degli amassi galattici.
La legge dei salti di qualità, a sua volta, consente di ottenere un punto di riferimento generale per anticipare e comprendere le proprietà emergenti, le novità e il livello crescente di organizzazione del nostro cosmo negli ultimi 13,8 miliardi di anni.
Pensiamo, ad esempio, alla straordinaria comparsa della vita, intesa giustamente nel 1943 dal grande fisico Erwin Schrödinger come la controtendenza locale rispetto all’entropia e alla seconda legge della termodinamica; e si deve focalizzare l’attenzione anche rispetto al processo altrettanto formidabile di emersione e sviluppo del pensiero autocosciente, in grado fin dai tempi della produzione dei primi chopper paleolitici di esprimere simultaneamente capacità di progettazione, di previsione di un determinato risultato materiale alla fine del lavoro, di una dinamica di autocreazione di un proprio fine autonomo di attività e di un’attenzione costante a tale scopo.
Sempre la legge dei salti di qualità indica la via maestra per prevedere il processo di trasformazione delle diverse potenzialità (ad esempio di una nube gassosa che vortica sempre più rapidamente) in realtà concreta, osservando la presenza di un determinato processo di accumulazione quantitativo (di gas e di pressione per formare una stella, nell’esempio ora in esame) giunto relativamente vicino al punto critico di rottura.
La legge dell’interconnessione globale tra i fenomeni naturali permette, dal canto suo, di prefigurare non solo la relativamente semplice azione/reazione tra le diverse cose ed entità naturali, ma anche le ulteriori ricadute di tale interrelazione con altri e diversi oggetti e dinamiche, creando pertanto un sistema globale a retroazione e una sorta di feedback su scala universale.[57]
L’azione combinata delle leggi generali in via di esame consente infine non solo di spiegare la presenza di livelli di organizzazione della materia, con leggi diverse di funzionamento al loro interno ma interconnessi e legati tra loro (l’effetto Casimir, ad esempio, esprime una connessione e interazione tra fluttuazioni quantistiche e mondo atomico) ma, allo stesso tempo, anche di prevedere che al massimo fra un paio di secoli, in assenza di guerra nucleare, si svilupperà un nuovo grado di esistenza del cosmo, formato dall’azione a spirale tra ingegneria genetica applicata sul corpo umano, modifiche su quest’ultimo invece create con pratiche di matrice cyborg, uso dei computer quantistici e continuo collegamento tra mente umana e intelligenza artificiale (Donna J. Haraway, Manifesto cyborg, ed. Feltrinelli).
“Avete dimenticato la famosa legge generale della lotta tra opposti, la famigerata contraddizione”.
Essa prevede, usando in senso ampio le parole del grande fisico R. P. Feynman, che anche in futuro «tutte le cose, ivi compreso l’uomo, “saranno” costituite da particelle positive e negative che interagiscono intensamente. Il tutto accuratamente equilibrato» (The Feynman lectures on Physics, capitolo secondo).
Può inoltre presagire che, anche nel futuro più remoto, continuerà quella dialettica cosmica tra materia e vuoto già descritta dal filosofo materialista Democrito venticinque secoli or sono, dinamica su scala universale che persisterà anche nel caso limite più estremo in qualità di simultanea unità e lotta tra vuoto quantistico e particelle-antiparticelle virtuali.
Può altresì pronosticare che anche in futuro si riprodurrà la natura sia ondulatoria che corpuscolare della luce e della radiazione: un’altra parte di un elenco che può essere facilmente allungato.
I frutti e i sottoprodotti della filosofia marxista non si arrestano comunque a questo punto.
Marx è stato anche un geniale e pionieristico filosofo della mente.
Da un lato, infatti, nel sopracitato poscritto del 1873 al Capitale, il grande scienziato di Treviri indicò lucidamente e correttamente che il pensiero, la mente, “l’elemento ideale non è altro che l’elemento materiale trasferito e tradotto nel cervello degli uomini”, notando pertanto fatti scientifici importanti quali il legame e il rapporto costante tra mente, corpo e universo, oltre al processo senza sosta di elaborazione dei dati sensoriali e della praxis umana condotta senza sosta dal cervello, dalle infinite interconnessioni (in via di continuo mutamento) tra i molti miliardi di neuroni contenuti in qualunque corpo umano.
Per quanto riguarda poi la questione del rapporto generale esistente tra pensiero (ivi comprese le sensazioni coscienti) e mondo esterno, indipendente dalla presenza e soggettività umana, Marx espose parzialmente nella prima delle Tesi su Feuerbach la teoria del riflesso-riproduzione attiva.
Da un lato, infatti, egli concordò con i materialisti precedenti che “l’oggetto, la realtà” erano riflessi e “concepiti” mediante “la forma dell’oggetto o dell’intuizione”, ma simultaneamente sempre tale “oggetto e realtà” venivano trasformati e riprodotti in modo cosciente dall’“attività umana sensibile”, dalla “prassi” sociale del genere umano.
Per fare un esempio concreto riguardante “la sensibilità” (Marx), da un lato l’apparato ottico umano vede e osserva le realtà esterna mediante gli impulsi forniti da quest’ultima, dagli “oggetti sensibili realmente distinti dagli oggetti del pensiero” (Marx), ma dall’altro la praxis collettiva della nostra specie è riuscita, nel corso dei secoli, ad aumentare in modo esponenziale il potere e a riprodurre creativamente anche il senso visivo attraverso tutta una serie di strumenti quali gli occhiali, il microscopio e il telescopio/telescopio spaziale.
Altre tipologie di riflesso-riproduzione attiva della realtà esterna provengono dalle stesse strutture dei sensi umani.
Per evidenti ragioni di sopravvivenza l’uomo rispecchia ad esempio lo spazio esterno, con i suoi pericoli reali o potenziali, ma altresì lo altera privilegiando in campo visivo la dimensione orizzontale rispetto a quella verticale: un uomo visto da venti metri di distanza risulta infatti molto più grande della stessa figura osservata alla stessa lontananza ma dall’alto, e l’elenco potrebbe essere facilmente ampliato a partire dal processo di trasformazione delle diverse lunghezze d’onda dello spetro visibile in determinati colori, attraverso l’azione dei coni della retina.
A un livello superiore della dinamica generale di riflesso-riproduzione attiva troviamo inoltre la biomimesi, a partire dall’imitazione del volo degli uccelli e degli scoiattoli volanti attraverso la costruzione di aerei e tute alari, oltre all’arte intesa come processo di raffigurazione e riproduzione, distorta e creativa, del mondo reale e dello stesso uomo al fine di suscitare e indurre emozioni e riflessioni, come avvenne ad esempio nei petroglifi degli aborigeni australiani risalenti a circa 40.000 anni fa, nelle loro espressioni rupestri più antiche.
E non solo.
Fin dai Manoscritti economico-filosofici del 1844, Marx ha individuato la polarità dialettica principale che contraddistingue il genere umano non solo mediante la categoria teorica del prometeismo, ma anche portando alla luce la fondamentale unità e lotta di opposti che fa sì che la nostra specie risulti da un lato un insieme di “esseri naturali” (Marx, Manoscritti) parti integranti del cosmo e della natura, e più precisamente una polvere di stelle dotata di DNA come tutte le altre specie viventi conosciute, ma che dall’altro lato e simultaneamente distingue e separa in modo decisivo l’homo sapiens da qualunque altra forma di vita terrestre.
Il processo di differenziazione nacque e si sviluppò fin dall’apparire del lavoro (Marx, Manoscritti) e della capacità di produrre strumenti di produzione con altri mezzi di lavoro, della connessa comparsa del potere di anticipare nel cervello come idea ciò che poi sarà il risultato del processo produttivo (Marx, “l’ape e l’architetto” nel primo libro del Capitale) e della forza di rendere il proprio fine lavorativo una “legge” del proprio agire, a cui l’essere umano deve subordinare la propria volontà (sempre Marx e sempre il quinto capitolo del primo libro del Capitale).
Fin dal 1844 e dai suoi Manoscritti economico-filosofici, il creativo, razionale e insuperabile maestro della psicologica “scuola del sospetto” (Paul Ricoeur) individuò uno dei principali e più antichi bias cognitivi umani, risalente a decine di migliaia di anni or sono, portando alla luce una potente tendenza e inclinazione collettiva a distorcere la realtà.
Già nei Manoscritti del 1844, Marx aveva infatti scoperto l’ultraremoto fenomeno mentale, sia individuale che di gruppo, dell’alienazione/reificazione: da intendersi come il processo intellettuale e bidirezionale sia di trasformazione delle cose in persone (si pensi solo ai feticci e ai totem paleolitici) che di mutazione invece degli essere umani in cose, come ad esempio avvenne per millenni nel caso particolarmente eclatante della valutazione degli schiavi come meri oggetti e strumenti, anche da parte di pensatori geniali come Aristotele.[58]
Per inciso, la dinamica dell’alienazione rischia di diffondersi anche rispetto alla rivoluzionaria intelligenza artificiale.
Ma quest’ultima non costituisce in alcun modo una forza immateriale e trascendentale, ma viceversa essa ha una matrice e un hardware materiali e rappresenta un prodotto del lavoro collettivo umano in tutti i sensi, dalla programmazione alla raccolta di dati: non ha proprietà magiche, ma i suoi poteri derivano solo da algoritmi a loro volta creati dall’uomo.
La genesi e il processo di riproduzione dell’intelligenza artificiale sono intrinsecamente connessi alla praxis umana e alle condizioni sociomateriali in cui essa viene creata e utilizzata come ad esempio nel caso, aperto a tutti e quasi completamente gratuito, dell’intelligenza artificiale cinese DeepSeek.
Infine, il materialismo dialettico, fin dai Manoscritti marxiani del 1844, ha contribuito direttamente al processo di sviluppo di una delle due sezioni più importanti della filosofia della scienza, quella legata all’analisi dell’homo sapiens e dei suoi antenati, portando alla luce la realtà storica e le categorie teoriche di autocreazione e autosviluppo umano basate sulla costruzione di mezzi di costruzione e sulla pratica produttiva, come del resto aveva intuito – ma solo intuito – il grande scienziato Benjamin Franklin nel Diciottesimo secolo: a tal proposito, è già stato citato in precedenza lo splendido brano di Engels intitolato “Parte avuta dal lavoro, nel processo di umanizzazione della scimmia”, contenuto nella spesso geniale Dialettica della natura.
Sempre Marx ed Engels avevano altresì messo in evidenza i decisivi salti di qualità che, sulla base di graduali e lente accumulazioni di conoscenza svoltesi in precedenza, avvengono sia in campo tecnologico (nel primo libro del Capitale Marx ad esempio descrisse la fondamentale connessione innescata da James Watt tra macchina a vapore e macchine utensili) che in quello scientifico: già nei suoi Manoscritti del 1844, Marx focalizzò l’attenzione sul gigantesco balzo in avanti raggiunto dalla praxis scientifica dopo il 1789 attraverso la scoperta di magnetismo, elettricità, protogeologia, ecc.
Il celebre libro di T. Kuhn, pubblicato nel 1962 e intitolato La struttura delle rivoluzioni scientifiche, ha in parte ereditato e sistematizzato le idee espresse in precedenza da Marx ed Engels sulla filosofia della scienza rispetto ai salti di qualità che segnano da molti secoli quest’ultima: idee e categorie storico teoriche ormai accettate da larga parte dei ricercatori e dei filosofi della scienza di matrice occidentale.[59]
“È tutto?”
Non ancora.
Nella Ideologia tedesca, Marx assieme ad Engels, infatti, individuò fin dal 1846 i “presupposti reali” del plurimillenario processo di riproduzione umana: categoria teorica che si può indicare anche come “sottostruttura”, mentre il filosofo Timothy Morton usa il termine di “iperoggetti”.[60]
Tra i “presupposti reali” in oggetto si possono indicare:
– le condizioni e mutamenti geologici, climatici, e “oro-idrografici” (Marx ed Engels) della Terra;
– il livello di radioattività naturale del nostro pianeta;
– il campo magnetico terrestre;
– lo strato di ozono;
– gli oggetti e micro-oggetti celesti che in ogni istante colpiscono l’atmosfera terrestre;
– la struttura genetica dell’homo sapiens sapiens, con i suoi incroci extra-africani con il genoma dei nostri cugini Neanderthal.
Per quanto riguarda invece le innovazioni teoriche introdotte da parte dei libri che via via pubblicheremo sul materialismo dialettico, vanno evidenziate:
– la scoperta del prometeismo cooperativo come elemento centrale della filosofia marxiana e marxista;
– la categoria teorica e pratica dell’uomo cosmico, nata dalla combinazione dialettica tra fattori quali i voli e i satelliti spaziali, la recente coscienza di essere “figli delle supernove” (le quali hanno via via prodotto quasi tutti gli elementi chimici) oltre alla consapevolezza della profonda dipendenza della Terra dall’universo anche solo per la caduta di asteroidi e l’azione del Sole e della Luna sul nostro pianeta;[61]
– il principio fondamentale della logica dialettica secondo cui A = A e anche non A, di fatto enunciato ed esposto da Marx già nel gennaio del 1873;
– Lenin e il processo di riproduzione creativa della realtà da parte degli uomini;
– le sopracitate quattro leggi generali della dialettica, esposte da Stalin nel 1938 e seppellite da un silenzio quasi secolare;
– l’azione continua e ininterrotta, nel livello di organizzazione della materia contraddistinta dalla vita organica, del processo costante all’interno di ogni organismo dell’unità e lotta tra vita e morte, creando un equilibrio dinamico ma instabile tra le forze che tendono alla sopravvivenza di ogni essere vivente e le controtendenze che, invece, portano alla degradazione e alla fine di questi ultimi;
– la lotta eonica della specie umana contro l’entropia universale, categoria teorica via via esposta da pensatori creativi quali Engels e Il’enkov;
– il titanismo di matrice cosmico-spaziale elaborato da K. Ciolkovskij;
– i diversi livelli di organizzazione della materia, a partire da quella del vuoto quantistico con le sue particelle-antiparticelle virtuali che si autodistruggono in tempi più infinitesimali;[62]
– i sei diversi centri di gravità del marxismo creativo degli ultimi due secoli: quello tedesco (1841-1895), russo (da Lenin al 1936), russo-cinese (dal 1937 al 1956), europeo (1957-76), quello cinese-denghista (1978-97) e, infine, il pensiero di Xi Jinping come il marxismo del Ventunesimo secolo;[63]
– la contraddizione tra il grado di potere e conoscenza della natura da parte del genere umano e i limiti, dati volta per volta, a quest’ultimo;
– l’opposizione tra le multilaterali potenzialità umane, divenute infinite fin dal momento della costruzione sistematica dei primi chopper, e i suoi ancora limitati poteri concreti e dati volta per volta, nel corso degli ultimi due milioni di anni;
– il processo di analisi delle grandi possibilità ma anche dei rischi insiti nelle rivoluzioni dell’RNA e dell’ingegneria genetica, della realtà virtuale e di quella aumentata, delle nanotecnologie e dell’intelligenza artificiale, della robotica avanzata e dei Big Data;
– la valorizzazione degli spunti filosofici corretti e stimolanti offerti via via dagli scienziati, quali ad esempio Pitagora con la sua dialettica tra finito e infinito ricavata dall’analisi dei numeri. Archimede e il metodo di approssimazione crescente alla realtà-verità (nel caso specifico, utilizzando il principio di esaustione per il valore del pi greco). G. W. Leibnitz mediante il sistema numerico binario contraddistinto tra unità e lotta tra stati opposti quali 0 e 1, base a sua volta della moderna informatica, oltre a B. Mandelbrot e alla sua teoria dei frattali, con la dialettica tra simultanea continuità e trasformazione degli stessi frattali, forme geometriche esistenti sia sul piano matematico che in natura.
Conclusioni
L’ininterrotta dialettica tra continuità e discontinuità in ogni fenomeno dell’universo, a tutti i livelli, costituisce il più rilevante sottoprodotto teorico della legge generale della trasformazione di qualunque fenomeno: e il nuovo, l’inaspettato, la potenzialità trasformatasi in realtà tanto apprezzata da Ernst Bloch rappresentano a loro volta la fonte principale di quella meraviglia umana che, come sostenne giustamente il grande Aristotele, genera e riproduce lo stesso processo di riflessione filosofica.
Nel corso degli ultimi decenni, abbiamo assistito alla nascita dell’intelligenza artificiale e dei computer-reti di connessione quantistiche; abbiamo osservato altresì dinamiche rivoluzionarie che, come nel Nicaragua del 1970/89, videro la presenza della religione come importante strumento di liberazione contro l’imperialismo, oltre al fenomeno gigantesco di centinaia di milioni di “uomini in carne e ossa” (Gramsci) che in un tempo relativamente rapido sono usciti dalla condizione di povertà assoluta, come è avvenuto in Cina, Vietnam e Laos.
Una quarta, oceanica e magmatica rivoluzione tecno-scientifica risulta ormai in atto proprio ora e proprio ai nostri giorni, seppur con i suoi limiti e le sue contraddizioni.
Se come genere umano sapremo sconfiggere, innanzitutto e come priorità, l’atroce demone dello sterminio nucleare – si pensi solo alle nichiliste dichiarazioni rese in merito dall’allora Ministro degli Esteri britannico Elisabeth Tuss, alla fine di agosto del 2022 – si aprirà un nuovo scrigno aureo, frutto della creatività collettiva umana e fonte di innumerevoli nuove sorgenti di stupore anche per il processo di pensiero filosofico.
Non sarà che un inizio…
In uno scenario epocale nel quale la concreta minaccia dell’autodistruzione per via atomica è ben presente e reale, come l’opposto processo di costruzione delle condizioni materiali per il comunismo sviluppato del “a ciascuno secondo i suoi bisogni” (automazione, robot in grado di apprendere, intelligenza artificiale, e così via), il materialismo dialettico serve a fornire le coordinate più generali per il processo di progettazione, previsione e praxis delle forze politico-sociali cooperative e umaniste della nostra specie.
La presenza di una Terra abitabile sia per l’homo sapiens che per le decine di milioni di altre specie viventi nel nostro pianeta costituisce un bene supremo, oltre che un presupposto assolutamente indispensabile per la nostra dinamica di riproduzione sociobiologica come avevano spiegato Marx ed Engels, all’inizio della loro Ideologia tedesca scritta nel lontano 1846.
A sua volta, la categoria analitica e la pratica di costante autoproduzione e autocreazione del genere umano, fin dalla costruzione dei primi chopper più di due milioni di anni fa, consente altresì di acquisire la piena autocoscienza, individuale e collettiva, che la storia è fatta e modificata da noi esseri umani, seppur agendo sempre in presenza di determinati rapporti di forza politico-sociali e di un certo livello di sviluppo, globale e locale, delle forze produttive: tutti siamo quindi chiamati in causa e all’azione, specialmente in tempi drammatici come quelli che viviamo attualmente.
Il principio generale dell’unità e lotta di opposti fa altresì in modo che si possa ottenere una lucida contezza sulla coesistenza conflittuale e senza sosta che vige all’inizio del terzo millennio, sull’antagonismo tra tendenze e controtendenze opposte ancora in bilico e ancora in equilibrio precario tra loro quali quelle:
– tese e finalizzate al dominio planetario, contrapposte a quelle invece intenzionate a creare un mondo pacifico e multipolare;
– indirizzate a sostenere l’imperialismo predatorio, finanziario e parassitario, contrastate dalle soggettività multiformi, a partire ovviamente dai comunisti, che operano per il socialismo su scala mondiale;
– che hanno assunto il ruolo all’interno delle metropoli imperialiste di “falchi” pronti, in caso di (loro…) necessità ad avviare l’olocausto nucleare, ostacolati dall’ancora troppo debole movimento planetario per la pace.
È ormai dal 1933, dopo l’ascesa rovinosa al potere del nazismo genocida, che la nostra specie non affronta un bivio e delle alternative storiche così radicalmente importanti e contrapposte, per esiti e ricadute di durata plurisecolare.
Il processo di riflessione filosofica entra a pieno titolo in questo scontro globale di spinte e controspinte anche perché, come annotò correttamente Marx nella sua sopracitata Critica alla filosofia del diritto di Hegel del 1843, la teoria “diventa una forza materiale non appena si impadronisce delle masse”.
Ma non solo.
All’inizio del quinto capitolo del primo libro del Capitale, Marx fece notare che in qualunque processo produttivo, e quindi anche nella paleolitica costruzione dei primi chopper di più di due milioni di anni fa, servono la capacità di progettazione (“al termine del processo lavorativo vien fuori un risultato che, al suo inizio, era già implicito nell’idea del lavoratore, che perciò era già presente idealmente”); la teleologia e il porsi dei fini precisi da parte dell’uomo lavoratore (il lavoratore “contemporaneamente realizza in questo il suo fine”); quest’ultimo “ha coscienza” dello scopo lavorativo, e quindi possiede un livello di autocoscienza del “fine” lavorativo che si è posto autonomamente, per via non genetica; il potere di autocontrollo e di attenzione del lavoratore durante la fase produttiva (sempre Marx, “il fine al quale deve subordinare la propria volontà”).
Si può allargare notevolmente l’elenco marxiano di tali qualità e caratteristiche, proprietà emergenti affermatesi già con la pratica-progettazione dell’homo habilis e via via sviluppatasi, affinatesi e migliorate enormemente a partire dal lontanissimo processo di produzione di chopper.
Tale dinamica, allo stesso tempo mentale e materiale, si verificò anche nei casi della capacità di previsione e della coscienza anticipante (procurandosi il materiale per costruire i chopper, organizzando la diverse fasi della creazione di quest’ultimo, ecc.), della libertà (l’homo habilis poteva, ma anche non poteva, riprodurre di frequente le prime pietre scheggiate ad arte), la capacità di vivere simultaneamente nel presente e nel futuro, attraverso la coscienza nel presente della produzione e degli utilizzi futuri del chopper e di numerosi altri poteri e potenzialità, ancora allo stato embrionale più di due milioni di anni or sono: poteri e potenzialità a cui dedicheremo in futuro un libro a parte, riutilizzando anche alcuni spunti contenuti nell’Ontologia dell’essere sociale di Lukács.
Le acquisizioni teoriche via via accumulate dalla rete di ricerca globale del materialismo dialettico, specialmente durante gli ultimi anni, risultano del resto ancora più evidenti se confrontate e paragonate con il panorama spettrale di fallimenti di matrice analitica e predittiva subiti, fra l’altro senza quasi un minimo di autocritica, dalla filosofia occidentale di sinistra a partire dagli inizi degli anni Settanta.
Non parliamo dell’allucinato filone del “spazzatura filosofica” in cui si inseriscono a pieno titolo il terrapiattismo, l’ecologismo radicale dello scienziato finlandese K. Pentti Linkola, secondo il quale la cancellazione della specie umana costituisce l’unica soluzione per la sopravvivenza per la biosfera, il primitivismo di John Zerzan, per cui l’intero genere umano deve tornare alla raccolta di cibo e alla caccia preistorica, senza neanche scrittura e matematica, e l’odio antiscientifico di personaggi quali la storica Carolyn Merchant, che sostiene che la natura sia stata uccisa proprio dalla concezione “meccanicistica” della scienza: tendenze molto particolari a cui si aggiunge l’antispecismo elaborato da P. Singer e T. Regan, teso ad annullare qualunque differenza di valore tra gli uomini e gli altri esseri viventi e incapace persino di riconoscere che, su circa un miliardo di specie vissute/estinte da quasi quattro miliardi di anni, solo gli esseri umani sono riusciti a costruire pietre scheggiate e ad addomesticare il fuoco, arrivando via via alle odierne esplorazioni spaziali.
Rimaniamo pure ai cosiddetti piani alti della presunta cultura antagonista del mondo occidentale.
Che fine ha fatto, ad esempio, l’impero mondiale, tendenzialmente pacifico e unificante, immaginato e fantasticato da Negri e Hardt nel loro voluminoso saggio intitolato, per l’appunto, Impero? Tale scenario globale è divenuto ancora più assurdo e ridicolo alla luce della guerra commerciale avviata a livello mondiale dall’attuale mandatario politico della frazione maggioritaria dell’imperialismo statunitense, ossia il nucleo politico dirigente del miliardario Donald Trump.[64]
Il libro Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi, pubblicato nel 1970, è contraddistinto a sua volta dalla critica alla cultura patriarcale di cui avrebbe fatto parte anche il tenebroso marxismo, si è trasformato in seguito in un legittimo “sputiamo sul femminismo neoborghese” attraverso la lucida e concreta analisi prodotta dalla filosofa statunitense Nancy Fraser, che ha mostrato come il neofemminismo sia via via diventato “l’ancella del capitalismo”: innanzitutto, rifiutando l’inclusiva eguaglianza tra donne e uomini a favore invece della tesi relativa alla differenza di tutte le donne, senza diversità e asimmetrie tra donne capitaliste e donne operaie, donne-colf e donne datrici di lavoro delle loro domestiche, donne speculatrici di borsa e donne delle pulizie all’interno dei mercati finanziari.[65]
Da parte sua, Jürgen Habermas ha dimostrato il valore – si fa per dire, certo – della sua ambigua e prolissa teoria sulla pacifica comunicazione all’interno delle società occidentali avanzate comunicando a tutto il mondo, nel corso del 1999, i “buoni motivi etici” che richiedevano e legittimavano il bombardamento di Belgrado e della Jugoslavia da parte della NATO.
Via via sono spuntati altri “filosofi della NATO” di sinistra a sostegno delle guerre, dirette o per procura, che hanno visto impegnato negli ultimi tre decenni l’imperialismo occidentale, come nel caso di Michael Walzer, Norberto Bobbio e Bernard-Henry Lévy.[66]
A loro volta i cosiddetti “nietzschiani di sinistra”, tra i quali in Italia spiccano filosofi quali Massimo Cacciari e Gianni Vattimo, facevano perno sul riconoscimento della “fine della razionalità classica e dialettica e l’emergere pieno, costruttivo, rifondativo e non distruttivo del pensiero negativo” (Cacciari).
Gli illustri pensatori in oggetto non si erano minimamente accorti, vista del resto la loro estraneità alla “razionalità classica e dialettica”, che uno dei loro principali ispiratori e maestri di pensiero, e cioè il reazionario Martin Heidegger, era rimasto ferocemente antisemita e simpatizzante del nazismo a livello teorico anche dopo il 1945, come hanno dimostrato gli orrendi Quaderni neri pubblicati a partire dal 2015.[67]
La corrente variegata dei “nietzschiani di sinistra”, del resto, non nacque e si generò in Italia ma, come ha sottolineato Jan Rehmann, attraverso un pensatore francese considerato “ultrarivoluzionario” quale Gilles Deleuze.
Deleuze contrappose alla presunta “metafisica” della contraddizione marxista una reale metafisica, fondata invece sulla differenza, valorizzando il Nietzsche “pluralista” e creando una supposta continuità teorica e ideale tra Nietzsche e Spinoza, basata e incentrata sul concetto di potenza: facendo finta di non sapere che potenza, per il primo, coincideva con violenza, volontà di sopraffazione e di affermazione della “bestia bionda” sugli inferiori “sottouomini”.[68]
In questo paesaggio di sinistri e decadenti ruderi intellettuali non poteva mancare infine anche l’ipermoderna filosofia della disperazione. ben esemplificata dall’onesto e acuto, ma depresso e nichilista, filosofo britannico Mark Fisher, secondo il quale era “più facile immaginare la fine del mondo che quella del capitalismo”.[69]
Che fare, dunque?
Sgombrare innanzitutto il campo dalle rovine teoretiche; chiudere finalmente l’epoca neo-altomedievale apertasi dalla metà degli anni Settanta, simile purtroppo per alcuni versi ai tempi bui della filosofia occidentale, dopo Boezio e prima di Anselmo d’Aosta e Gaunilone.
Bisogna dunque porre termine al processo di decadenza della filosofia occidentale contraddistinto anche dall’assenza di emersione, in cinque decenni, di almeno una splendida eccezione come quella invece costituita nell’alto medioevo da Giovanni Scoto Eriugena (810-877): un geniale filosofo irlandese da cui si dipanò, nel mondo occidentale, il filo rosso costituito dalla valorizzazione del ruolo eccezionale e delle grandi potenzialità del genere umano, matrice che sarà in seguito sviluppata in forme variegate da Ruggero Bacone, Pico della Mirandola, Francis Bacon e dall’eroico Giordano Bruno, fino ad arrivare al livello superiore rappresentato dal prometeismo comunista di Marx.[70]
Non è un caso che il miglior prodotto della filosofia anticomunista, nel corso dell’ultimo secolo, si ritrovi nello splendido esperimento mentale e filosofico-letterario effettuato dallo scrittore (reazionario ma a volte geniale) J. L. Borges, e contenuto in un suo spettacolare racconto del 1940 intitolato Tlön, Uqbar, Orbis Tertius: al suo interno il romanziere argentino immaginò un universo alternativo nel quale si credeva con totale sicurezza che la mente e lo spirito creassero tutte le cose, traendo subito con perizia sia artistica che teoretica tutte le assurde e insensate conclusioni derivanti, inevitabilmente e logicamente, dal (presunto) funzionamento di tale mondo ucronico.
Quali conseguenze?
«Questo monismo o idealismo totale invalida la scienza. Spiegare (o giudicare) un fatto, è unirlo a un altro fatto: ma questa unione su Tlön corrisponde a uno stato posteriore del soggetto e non si applica allo stato anteriore, dunque non lo illumina.
Ogni stato mentale è irriducibile: il solo fatto di nominarlo – id est, di classificarlo – comporta una falsificazione. Da ciò, sembrerebbe potersi dedurre che su Tlön non si danno scienze, né ragionamento di sorta…».
Nell’universo parallelo di Tlön il cosmo non costituisce e non rappresenta “un concorso di oggetti, una serie eterogenea di arti indipendenti; è successivo, temporale, non spaziale”.[71]
Per la filosofia occidentale, risulta ormai indispensabile “uscire da Tlön”, ossia dal mondo malato, irreale e fantasmagorico delle teorie ontologiche idealiste, di matrice soggettiva o oggettiva, per ridare finalmente il suo contributo al processo creativo e antidogmatico di costruzione del “materialismo dell’umanità socializzata”, come richiesto da Marx nella decima Tesi su Feuerbach.
Concetti e categorie teoriche di livello sofisticato quali la dematerializzazione attraverso la sorveglianza e la digitalizzazione (Zygmunt Bauman), “la metafisica concreta” di Massimo Cacciari e la teoria della decrescita (Serge Latouche, Kohei Saito) si sommano alla tecnofobia ormai diffusa a livello di massa nel mondo occidentale, per formare assieme un mosaico variegato di trappole di matrice eterea e idealista con un diverso livello di sofisticazione che infesta “l’universo di Tlön” delle metropoli imperialiste contemporanee.
Si tratta di un cosmo idealistico e particolare nel quale si finge, ad esempio, di non sapere che la dematerializzazione digitale del cartaceo viene accompagnata dialetticamente dal simultaneo processo di costruzione della più grande infrastruttura materiale su scala planetaria della storia, in conseguenza della quale uno smartphone di 200 grammi incorpora un peso ecologico reale di ben settanta chilogrammi, mentre un microchip di soli 5 grammi porta con se la quasi incredibile cifra di 3000 chilogrammi di impronta materiale.
Siamo in presenza di un altro dei pesi e delle catene gravose da cui il genere umano deve liberarsi, all’inizio del terzo millennio.[72]
Dinamica di liberazione complessa e multilaterale, che passa anche per la strada importante della riflessione teorica rispetto ai principali problemi ontologici e gnoseologici del genere umano: una via di alto valore che deve avere necessariamente sia un respiro planetario che l’assimilazione-superamento in meglio (Lenin) dei più avanzati prodotti analitici della nostra specie.
A tal fine, il materialismo dialettico costituisce ormai da quasi due secoli la splendida sintesi-archivio e memoria collettiva della sezione migliore del pensiero filosofico mondiale, ivi compreso ovviamente quello di matrice orientale.
Il marxismo ha infatti costruito una serie di evidenti legami e connessioni, seppur con un forte lato critico, rispetto alla dialettica hegeliana.
Il materialismo risulta altresì strettamente unito con le lezioni che provengono dalla sezione più progressista dell’illuminismo settecentesco, condividendo totalmente l’audace moto dell’“osare sapere” enucleato da Kant nel 1784 e nel suo saggio Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo?: e, anzi, ne ha allargato la portata e l’impatto difendendo anche l’imperativo categorico di osare trasformare il mondo, sé stessi e il genere umano.
Se, da un lato, il marxismo innalza e porta a un livello superiore il pensiero materialistico di Democrito, Leucippo e della scuola indiana dei cārvāka del sesto secolo a.C., oltre che degli altri materialisti fino ad arrivare a Feuerbach, dall’altro lato esso adotta e fa fare un salto di qualità alla teoria dell’unità degli opposti scoperta, autonomamente e in contesti molto diversi, dalla scuola cinese dello yin e yang, dal fondatore del Taoismo cinese Laozi e dal filosofo greco Eraclito.[73]
Il materialismo dialettico riesce altresì a integrare e far fiorire al suo interno, a un grado molto superiore di elaborazione, anche notevoli conquiste del pensiero orientale quali i due principi ontologici della totalità e dell’interconnessione universale, sintetizzati nel pensiero buddhista dalla metafora delle gemme incastonate le une nelle altre nella “rete di Indra” ed elaborate sul piano sistematico da Hegel nella sua geniale, anche se erroneamente di matrice idealista, Fenomenologia dello spirito del 1807.[74]
Capacità di sintetizzare a un livello superiore i risultati più elevati del passato e, simultaneamente, potere di proiezione e anticipazione concreta e bilanciata verso il futuro, sia quello prossimo che quello più remoto.
Il filosofo tedesco Ernst Bloch scrisse con razionale passionalità, nel suo lavoro Dialettica e speranza del 1967, che “con un balzo verso il nuovo, di cui la storia non presentava sino ad ora esempio, comincia per mezzo di Marx – con la continuazione e insieme il superamento di Hegel – la trasformazione della filosofia in filosofia della trasformazione del mondo. La filosofia non è più filosofia se non è dialettico-materialistica, ma deve egualmente restare salda ora e nell’avvenire.
Il materialismo dialettico non è tale se non è filosofico, cioè se non procede in vasti aperti orizzonti”.[75]
Deve cioè procedere verso il vasto e aperto orizzonte della costruzione del regno della libertà, del comunismo sviluppato nel quale varrà la regola aurea del “a ciascuno secondo i suoi bisogni”.
Vi è ancora un lungo percorso da fare per arrivare a tale obiettivo da parte dei comunisti di tutto il mondo.
Ma essi sono concretamente favoriti in tale titanica impresa dal materialismo dialettico, come hanno spiegato splendidamente e pubblicamente i comunisti cinesi nell’ottobre del 2017, in un articolo pubblicato dall’autorevole Quotidiano del Popolo e letto da decine di milioni di cinesi.
In esso si riportava che “i marxisti interpretano il mondo attraverso il materialismo dialettico”.
Contraddizioni – o “forze in opposizione dinamica” – sono onnipresenti nella società e guidano il cambiamento sociale. La “contraddizione principale” è ciò che definisce una società.
Identificandola e risolvendola, la società si sviluppa pacificamente. Lasciata invece irrisolta, essa può portare al caos e, come Marx predisse, alla rivoluzione.
A sua volta G. Zjuganov, autorevole segretario del Partito Comunista della Federazione Russa, in una sua intervista dell’ottobre del 2022 ha dichiarato che le idee contenute nel pensiero di Xi Jinping «costituiscono un importante contributo innovativo allo sviluppo della teoria marxista» e «una chiave di lettura fondamentale per i processi in corso nel mondo»: il materialismo dialettico aiuta pertanto l’acquisizione di una corretta autocoscienza collettiva, di valore mondiale e senza fare distinzioni tra Oriente e Occidente, rispetto al contrastato processo di sviluppo che da milioni di anni vede come protagonista il genere umano e che, a determinate condizioni, continuerà anche nei prossimi secoli.
Il comunismo è la cosa facile che è difficile a farsi (Brecht), ma le coordinate teoriche fornite dal materialismo dialettico hanno aiutato in passato, aiutano tuttora e aiuteranno in futuro i comunisti a liberare l’intero genere umano da guerre, povertà e sfruttamento tra classi e tra nazioni.[76]
Il processo di sviluppo futuro imperniato sul materialismo dialettico possiede del resto un cuore antico, anzi di remotissima origine paleolitica.
Secondo l’etnologo francese Claude Lévi-Strauss, infatti, le popolazioni di cacciatori-raccoglitori che vennero studiate durante il Ventesimo secolo avevano riprodotto, in una lunga tradizione storica, una logica binaria di pensiero fondata principalmente su opposizioni strettamente interconnesse tra loro quali luce e oscurità, caldo e freddo, vita e morte, natura e cultura e così via: logica binaria e paleolitico pensiero dialettico la cui esistenza concreta viene provata con certezza dalle numerose sepolture rituali compiute dall’uomo di Neanderthal circa 400.000 anni fa, nel sito spagnolo di Sima de los Huesos.[77]
In questa logica dialettica di matrice paleolitica si ritrova e spicca anche il processo continuo di unità e lotta tra lati opposti quali la veglia/realtà e il sonno/sogno, dinamica variamente espressa in forme a volte molto creative, come nel caso della cultura e della cosmovisione plurimillenaria degli aborigeni australiani.
Una dialettica dal “cuore antichissimo” che è stata riprodotta a un livello superiore dal materialismo dialettico attraverso il “sogno di una cosa” delineato da Marx nel 1843 e con il Che fare? di Lenin, pubblicato nel 1902: in tale opera il geniale rivoluzionario e filosofo russo citò, con vivida approvazione, la tesi espressa dallo studioso D. I. Pisarev.
Scriveva Pisarev a proposito del contrasto tra il sogno e la realtà: «C’è contrasto e contrasto. Il mio sogno può precorrere il corso naturale degli avvenimenti, ma anche deviare in una direzione verso la quale il corso naturale degli avvenimenti non può mai condurre.
Nella prima ipotesi, non reca alcun danno: anzi, può incoraggiare e rafforzare l’energia del lavoratore… In quei sogni non c’è nulla che possa pervertire o paralizzare la forza operaia: tutt’al contrario. Se l’uomo fosse completamente sprovvisto della facoltà di sognare in tal maniera, se non sapesse ogni tanto andare oltre il presente e contemplare con l’immaginazione il quadro compiuto dell’opera che è abbozzata dalle sue mani, quale impulso, mi domando, l’indurrebbe a cominciare e a condurre a termine grandi e faticosi lavori nell’arte, nella scienza e nella vita pratica? Unione e lotta di opposti e tendenze contrastanti, ancora una volta».[78]
Tra l’altro, l’estensione del mosaico di polarità formatosi nella preistoria si amplia ulteriormente attraverso la dialettica concreta avviatasi quasi due milioni di anni fa, e che produrrà poi nel neolitico e nell’età del bronzo i culti del fuoco e il celeberrimo mito di Prometeo: fuoco da intendersi anche come simbolo della cultura umana da un lato e, dall’altro, la meravigliosa natura inorganica e organica che non comprende al suo interno la nostra specie.[79]
Sogni ad occhi aperti oppure onirici, e fuoco materiale ma anche di natura simbolica.
Un fuoco intellettuale che trovò nell’epoca moderna la sua vetta più alta proprio nel pensiero multiforme e dialettico di Karl Marx: non solo il più grande genio del passato millennio ma anche il moderno Prometeo dei nostri tempi, capace di indicare la via maestra e i mezzi da utilizzare per il processo di liberazione, plurilaterale e a lungo termine, del genere umano, per creare un mondo nuovo nel quale “i più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti”, come scrisse il grande poeta Nazim Hikmet.
Ma nel mondo occidentale regna invece un clima generale di pessimismo e apatia, si potrebbe ribattere.
A tal proposito lasciamo parlare un altro poeta, che riesce a render più concreta e a far vibrare al meglio l’“algebra della rivoluzione” (A. Herzen): si tratta di Bertolt Brecht e della sua formidabile Lode della dialettica, scritta nel 1933 dopo l’ascesa al potere di Hitler.
L’ingiustizia oggi cammina con passo sicuro.
Gli oppressori si fondano su diecimila anni.
La violenza garantisce: Com’è, così resterà.
Nessuna voce risuona tranne la voce di chi comanda e sui mercati lo sfruttamento dice alto: solo ora io comincio.
Ma fra gli oppressi molti dicono ora: quel che vogliamo, non verrà mai.
Chi ancora è vivo non dica: mai!
Quel che è sicuro non è sicuro.
Com’è, così non resterà.
Quando chi comanda avrà parlato, parleranno i comandati.
Chi osa dire: mai?
A chi si deve, se dura l’oppressione? A noi.
A chi si deve, se sarà spezzata? Sempre a noi.
Chi viene abbattuto, si alzi!
Chi è perduto, combatta!
Chi ha conosciuto la sua condizione, come lo si potrà
fermare?
Perché i vinti di oggi sono i vincitori di domani e il mai diventa: oggi!
Nel terzo millennio e un secolo dopo il severo elogio di Brecht, la posta in palio per la nostra specie si è ancora alzata di livello, diventando ormai la secca alternativa tra l’autodistruzione dell’umanità a causa di una guerra nucleare – di cui Auschwitz, Hiroshima e il genocidio perpetrato a Gaza da Israele costituiscono gli orrendi segni premonitori di una fine nell’orrore – e l’avvio invece di un lungo processo di costruzione del comunismo della gratuità e dei robot come principale forza produttiva, dell’energia pulita su una scala sempre crescente e della ripulitura del nostro pianeta dalla variegata spazzatura gettata via via su di esso, con la plastica arrivata al fondo degli oceani; impedendo, con la scelta della seconda strada in oggetto, che una storia di milioni di anni si perda nel nulla come lacrime nella pioggia e, simultaneamente, consentendo a noi umani di vedere nel futuro quei sogni marxiani di una cosa e quei raggi B balenanti nel buio vicino alle porte di Tannhäuser che desideriamo vengano concretizzati, almeno nella parte migliore dei nostri cuori e delle nostre menti.
Faro e filo di Arianna indispensabile al fine di orientarsi nella struttura multiforme e dinamica dell’universo, ivi compreso lo sviluppo degli ominidi divenuti in grado di produrre pietre scheggiate, il materialismo dialettico serve altresì non solo per alimentare il senso del nuovo e della meraviglia ma anche per produrre autocoscienza sul ruolo iperpotente dimostrato dalla nostra specie in determinate situazioni, attraverso capolavori quali i dipinti delle grotte di Lascaux e della Cappella Sistina, della Scuola di Atene di Raffaelo e di Guernica di Picasso, la grande Muraglia Cinese e il sito di Petra, il Cremlino e il Taj Mahal, le sonorità musicali di Mozart e di Beethoven, dei Beatles e dei Pink Floyd.
Dotato tra l’altro di un patrimonio genetico appartenente in media per il 2% ai nostri estinti cugini di Neanderthal, l’homo sapiens sapiens è riuscito negli ultimi due decenni a creare e costruire nuove meraviglie e incanti di matrice tecnoscientifica come le migliaia di robot umanoidi in grado di ballare sincronicamente a Pechino nell’agosto del 2025, la pelle sintetica, le retine e il sangue artificiale, la stampa 3D già ora capace di modellare case e l’intelligenza artificiale generativa che, dal 2014, fa competere e cooperare tra loro due reti neurali al fine di produrre nuovi dati e informazioni.
È solo un inizio, si può affermare parafrasando la voce collettiva degli studenti e degli operai francesi in lotta nel maggio 1968.
[1] E. Hobsbawm, “Come cambiare il mondo”, ed. Rizzoli;
- Agosti, “La Terza Internazionale”, vol. 2, parte prima, p. 183, Editori Riuniti.
[2] G. A. Wetter, “Il materialismo dialettico sovietico”, ed. Einaudi.
[3] F. Stonor Saunders, “La guerra fredda culturale: la CIA e il mondo delle lettere e delle arti”, ed. Fazi.
[4] T. Adorno e M. Horkheimer, “Dialettica dell’illuminismo”, ed. Einaudi;
- Žižek, “Meno di niente. Hegel e l’ombra del materialismo dialettico”, ed. Ponte alle Grazie.
[5] Y. N. Harari, “Da animali a dei: breve storia dell’umanità”, ed. Bompiani.
[6] M. Waldenberg, “Il papa rosso”, Editori Riuniti.
[7] D. Mclennan, “Marx”, ed. Il mulino;
- Eagleton, “Marx”, ed. Sansoni;
- Musto, “Karl Marx: biografia intellettuale e politica”, ed. Einaudi;
- Favilli, “Storia del marxismo italiano. Dalle origini alla grande guerra”, ed. Franco Angeli.
[8] J.-Y. Calvez, “Il pensiero di Karl Marx”, ed. Città nuova; J. M. Bochenski, “Soviet Russia dialectical materialism [Diamat]”, ed. Springler.
[9] D. Fusaro, “Idealismo e praxis: Fichte, Marx e Gentile”, ed. Il melangolo.
[10] G. V. Plechanov, Opere scelte, p. 270, ed. Progress.
[11] G. Lukács, “Esistenzialismo o marxismo?”, p. 48, ed. Acquaviva; Trần Đức Thảo, “Fenomenologia e materialismo dialettico”, ed. Lampugnani Nigro.
[12] Mao Zedong, “Da dove provengono le idee giuste?”, 1963.
[13] G. W. F. Hegel, “Scienza della logica”, p. 170, ed. Feltrinelli.
[14] B. Groys, “Element of gnosticism in dialectical materialism (soviet marxism)”, maggio 2022, in e-flux.com; “Divinità induiste”, in wikipedia.it;
- Filoramo, “L’attesa della fine: storia della gnosi”, ed Laterza.
[15] L. Althusser, “Per Marx”, p. 153, Editori Riuniti.
[16] J. Bellamy Foster e B. Clark, “The dialectical ecologist: Richard Levins and the science and praxis of the human-nature metabolism”, 1º gennaio 2025, in monthlyreview.org.
[17] AA. VV., “Stephen Jay Gould. La vita meravigliosa”, p. 18, in pikaia.eu.
[18] S. Schmalzer, “Red revolution, green revolution: scientific forming in socialist China”, University of Chicago Press.
[19] J. Bellamy Foster e B. Clark, op. cit.; L. Geymonat, “I rapporti tra scienza e filosofia in URSS”, in Storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. sesto, ed. Garzanti.
[20] R. L. Numbers, “On humans, dinosaurs, and Sarah Palin”, 1° ottobre 2008, in Harvard University Press;
- I. Lenin, “Materialismo ed empiriocriticismo”, p. 20-21, Editori Riuniti.
[21] Bhattacharya Ramkrishna, “Studi sul carvaka-lokayata”, in Inno Press.
[22] D. B. Davis, “Il problema della schiavitù nella cultura occidentale”, ed. SEI;
- Coniglio, “Il concetto di schiavitù in San Tommaso d’Aquino”, in jstor.org.
[23] A. Damasio, “L’errore di Cartesio”, ed. Adelphi; “Alla ricerca di Spinoza”, ed. Adelphi.
[24] “Quasi ancora la metà degli americani crede nel creazionismo”, 4 giugno 2012, in wallstreetitalia.com;
- Engels, “Parte avuta dal lavoro nel processo di umanizzazione della scimmia”, maggio-giugno del 1876, in dsu.univr.it.
[25] F. Engels, “Anti-Dühring”, pp. 144-145, Editori Riuniti.
[26] G. Lukács, “Prefazione del 1967” a “Storia e coscienza di classe”, ed. Mondadori.
[27] E. Agazzi, F. Minazzi e L. Geymonat, “Filosofia, scienza e verità”, ed. Rusconi;
- Barletta, “Marxismo e teoria della scienza”, ed. Dedalo.
[28] “Effetto Casimir”, in wikipedia.it; “Bosone di Higgs”, in wikipedia.it.
[29] M. Barsuglia, “La rivoluzione delle onde gravitazionali”, ed. Hoepli.
[30] V. Novara, “Meccanica quantistica: il principio di sovrapposizione”, 21 settembre 2021, in passioneastronomia.it;
- Burgio, M. Leoni e R. Sidoli, “Logica dialettica e l’essere del nulla”, p. 23, l’AD Edizioni.
[31] M. Musso, “Compie un secolo il più grande errore di Einstein”, 13 febbraio 2017, in wired.it;
“L’universo si espande più velocemente del previsto: nuove prove a sostegno”, 21 gennaio 2025, in hdblog.it.
[32] K. Korsch, “Marxismo e filosofia”, p. 50, ed. Sugar.
[33] B. Groys, “Introduzione all’antifilosofia”, ed. Mimesis.
[34]K. Korsch, “Crisi del marxismo” in “Dialettica e scienza del marxismo”, pag. 139, ed. Laterza.
[35] K. Korsch, “Hegel e la rivoluzione”, in “Dialettica e scienza…”, pp. 168-169, op. cit.
[36] M. Foucault, “L’archeologia del sapere”, pp. 30 e 31, ed. Rizzoli.
[37] S. Belardinelli, “Studiare le meduse per conoscere la storia del sistema nervoso”, 12 gennaio 2022, in ilbolive.it.
[38] K. Marx, “Manoscritti economico-filosofici”.
[39] Dice infatti: «Se materialismo fondamentalmente non significa altro che l’eliminazione dell’“inversione ideologica” della dialettica hegeliana, allora materialismo significa anche la dottrina secondo la quale i concetti formati dal pensiero devono essere considerati copie delle cose reali, e non le cose reali “riflessi” dei concetti». Quindi che ci sia una differenza tra il pensiero e la realtà esterna e che si istauri un rapporto dialettico tra questi Wetter non lo arriva a capire o comunque ad accettare.
[40] Stalin, “Le deviazioni di destra nel Partito Comunista (bolscevico) dell’Unione Sovietica”, aprile 1929.
[41] «Ci troviamo così di fronte all’alternativa: o ammettiamo un vero e proprio salto qualitativo, e allora l’intera serie di intermediari serve a ben poco, dato che allora ritorna in ognuno o almeno in uno di quei gradini il problema del come spiegare il passaggio discontinuo a qualcosa di sostanzialmente diverso, oppure consideriamo la catena d’intermediari come la soluzione di questo problema e allora implicitamente ritorniamo alla posizione del materialismo meccanicistico».
[42] «La spiegazione dovrebbe essere nel fatto che a un determinato punto i cambiamenti quantitativi si trasformano con un salto in cambiamenti qualitativi. Ma il salto non spiega affatto l’emergenza della qualità nuova; può soltanto, nel migliore dei casi, descrivere tale passaggio. Esso non risponde alla domanda “perché” emerga un nuovo fenomeno, ma risponde solo alla domanda “come” scaturisce»/
[43] I. Kant «Ma rispetto allo stato delle mie finanze nei cento talleri reali c’è più che nel semplice concetto di essi», Critica della ragion pura.
[44] «La conferma del pensiero mediante il successo nella prassi può essere ottenuta soltanto attraverso un nuovo atto conoscitivo, la cui verità dovrebbe essere dimostrata da una nuova prassi.» Si va alla ricerca de «l’ultima giustificazione critica della validità oggettiva della nostra conoscenza in genere». Se è pur corretto asserire che tutte le teorie scientifiche sono sempre sottoposte a revisione in base a nuovi fatti, qui si mina il fondamento dei “fatti”.
[45] I. V. Stalin, “Materialismo dialettico e materialismo storico”, 1938;
- Lefebvre, “Il materialismo dialettico”, ed. Einaudi 1947.
[46] V. Afanas’ev, “Fondamenti di filosofia marxista-leninista”, ed. Progress;
- Šeptulin, “La filosofia marxista-leninista”, ed. Progress.
[47] F. Engels, “Dialettica della natura”, Editori Riuniti;
- Melia, A Pascale, “Stalin e le quattro leggi generali della dialettica”, ottobre 2024, in mondorosso.wordpress.org.
[48] R. Carnap, “Analicità, significanza, induzione”, p. 157, ed. Il Mulino.
[49] K. Popper, “Conoscenza oggettiva”, pp. 70, 416 e 87, ed. Armando.
[50] “Compie un secolo il più grande errore di Einstein”, 13 febbraio 2017, in wired.it.
[51] M. Debernardi, “Le radici dell’epistemologia evolutiva: Lorenz, Popper, Campbell”, in boa.unimib.it
[52] K. Kangal, “La dialettica emergentista di Engels”, in monthlyreview.org.
[53] “Dilatazione temporale gravitazionale”, in it.wikipedia.org.
[54] J. L. Borges, “Nuova confutazione del tempo”, in killingbuddha.altervista.org.
[55] L. Geymonat, “Paradossi e rivoluzioni”, p. 121, ed. Il Saggiatore.
[56] L. Billings, “Gli astronomi assistono per la prima volta alla nascita di un sistema solare alieno”, 18 luglio 2025, in lescienze.it.
[57] L. Apostel, “Materialismo dialettico e metodo scientifico”, ed. Einaudi.
[58] M. Sferini, “La regola critica della scuola del sospetto”, 17 marzo 2024, in lasinistraquotidiana.it.;
- Ricoeur, “Riflession fatta. Autobiografia intellettuale”, ed. Jaca book.
[59] T. S. Kuhn, “La struttura delle rivoluzioni scientifiche”, ed. Feltrinelli.
[60] S. Timpanaro, “Sul materialismo”, ed. Unocopli;
- Morton, “Iperoggetti”, ed. Feltrinelli.
[61] A. Banfi, “L’uomo copernicano. Saggi di filosofia critica”, ed. Mimesis;
- Baraldi, “Come vivremo nello spazio: storia e futuro dell’uomo che abiterà l’universo”, ed. Gribaudo.
[62] G. Lukács, “Per l’ontologia dell’essere sociale”, vol. primo, Editori Riuniti.
[63] Mao Zedong, “Sulla pratica”, luglio 1937; “Sulla contraddizione”, agosto 1937; “Sull’esperienza storica della dittatura del proletariato”, 4 aprile 1956; “Sui dieci grandi rapporti”, 25 aprile 1956.
[64] M. Hardt e T. Negri, “Impero”, ed. Rizzoli.
[65] C. Lonzi, “Sputiamo su Hegel e altri scritti”, ed. La Tartaruga;
- Fraser, “Come il femminismo divenne ancella del capitalismo”, 20 ottobre 2013, in sinistrainrete.info.
[66] L. Baccelli, “Riecco la “guerra giusta” di Michael Walzer”, 9 giugno 2022, in il manifesto.it
[67] D. Losurdo, “Nietzsche, il ribelle aristocratico”, ed. Bollati Boringhieri;
- Heidegger, “Quattro quaderni I e II 1947-50”, ed. Bompiani;
- L. Andriola, “Una sinistra che sdoganò l’estrema destra”, 2 agosto 2019, in osservatorioglobalizzazione.it.
[68] I. Rehmann, “I nietzscheani di sinistra”, ed. Odradek.
[69] M. Fisher, “Realismo capitalista”, ed. Nero.
[70] E. Gilson, “La filosofia nel medioevo”, p. 264, 265, 575, 577, ed. La Nuova Italia.
[71] J. L. Borges, “Tlon, Uqbar, Orbis Tertius”, in “Finzioni”, ed. Adelphi.
[72] G. Pitron, “Inferno digitale”, ed. Luiss;
- Gallina, “Tecnofobia”, ed. Aldenia;
- Cacciari, “Metafisica concreta”, ed. Adelphi;
- Bauman, “La materialità liquida”, ed. Laterza;
- Latouche, “La scommessa della decrescita”, ed. Bollati Boringhieri;
- Saito, “Il Capitale nell’Antropocene”, ed. Einaudi.
[73] “Eraclito: la luce dell’oscuro”, a cura di G. Fornari, ed. Olschki;
“Il libro degli insegnamenti di Lao Tzu”, a cura di T. Cleary, ed. Mondadori.
[74] G. W. F. Hegel, “Fenomenologia dello spirito”, ed. Armando;
- I. Lenin, “Tre fonti e tre parti integranti del marxismo”, marzo 1913.
[75] E. Bloch, “Dialettica e speranza”, ed. Vallecchi.
[76] “China embraces new “principal contradiction” when embarking on new journey”, 21 ottobre 2017, in en.people.cn.
[77] C. Lévi-Strauss, “Il pensiero selvaggio”, ed. il Saggiatore;
- L. Arsuaga, “I primi pensatori e il mondo perduto di Neanderthal”, ed. Feltrinelli.
[78] V. I. Lenin, “Che fare?”, capitolo quinto, paragrafo b.
[79] C. Perles, “Preistoria del fuoco: alle origini della storia dell’uomo”, ed. Einaudi.
STORIA DEL COMUNISMO

Storia del Comunismo. Le lotte di classe nell’era del socialismo (1917-2017).
Un secolo di storia contemporanea riletto in 4 tomi con la metodologia del materialismo storico. A cura di Alessandro Pascale, storico e insegnante.
STORIA DEL SOCIALISMO E DELLA LOTTA DI CLASSE
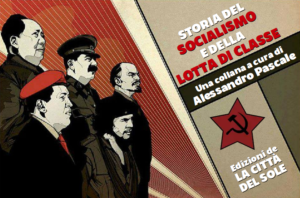
A partire dai materiali di “In Difesa del Socialismo Reale”, nasce una nuova collana, pubblicata in 10 volumi da La Città del Sole.
Clicca qui per maggiori informazioni
Partecipa al finanziamento del progetto facendo un’offerta.
IL TOTALITARISMO “LIBERALE”. LE TECNICHE IMPERIALISTE PER L'EGEMONIA CULTURALE
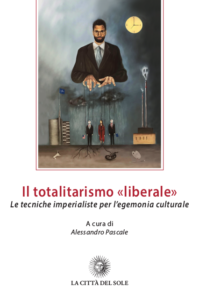
Il primo volume della collana “Storia del Socialismo e della Lotta di Classe”. Uscito nelle librerie nel gennaio 2019 al costo di 25 euro; Per info sull’opera e sull’acquisto clicca qui.

